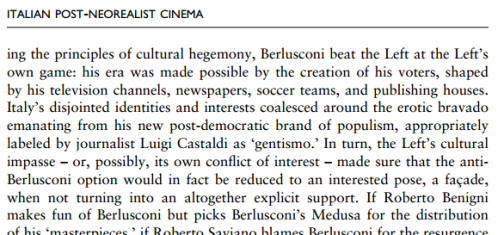Ci fu
un tempo in cui quello che oggi è detto (molto impropriamente)
“populismo” era assai meno arcigno (fiero di
sé, ma con un indugio che poteva sembrare – e forse davvero era –
pudore); e volgare, sì, ma mai troppo sguaiato (soffriva il biasimo
di chi non lo poteva soffrire); e rifuggiva da posture smargiasse
(tutt’al più esibiva l’orgoglio di un candore primitivo); e mai
si sarebbe azzardato a rivendicare con l’alterigia del fesso
giulivo lo statuto prepolitico (era ancora folk, mancavano decenni
dal diventare bifolco); ma, più di tutto, neanche sapeva di essere
“populismo” (non poteva saperlo perché
nessuno gli aveva mai affibbiato quell’epiteto), e si limitava a
dichiararsi “sentimento nazional-popolare” (così lo
chiamavano, così si adattò a farsi chiamare). Ogni rinuncia
all’articolazione era “nazional-popolare”, ogni
compiacersi di semplicità, genuinità, schiettezza, che in realtà
erano semplicismo, piattezza, trasparenza per mancanza di qualsivoglia spessore, erano “nazional-popolari”,
e così le frasi fatte, i luoghi comuni, la più immediata apparenza
di verità assoluta che anche la sola analisi grammaticale sarebbe
stata in grado di decostruire in tautologia: tutto era
“nazional-popolare” e, giacché al termine qualcuno aveva
conferito la stessa dignità che si conferisce al tonto che può
eventualmente diventare un Parsifal, il “nazional-popolare”
cominciò a pretendere un blasone. E finì con l’ottenerlo. Grazie
a Pippo Baudo, grazie a Toto Cutugno, grazie ai fratelli Vanzina, forse perfino grazie alle scoregge di Alvaro Vitali, e
direi possa bastare, credo abbiate capito.
Molto
è cambiato da allora, al punto che si fa enorme fatica a risalire
lungo l’albero genealogico di questa schiatta, peraltro ricavando
un certo disorientamento nel comparare all’oggi i suoi antecedenti.
D’altronde, si sa, nessuno rimane uguale a quel che era, quando
nel corso della sua evoluzione deve disfarsi di ciò che gli è di
impaccio, per acquistare ciò che può tornargli utile per meglio
adattarsi all’ambiente. Di converso: se l’ambiente non impone la
selezione, che bisogno c’è di cambiare?
Vorrete un esempio, credo.
Va bene, prendete Umberto Eco: dai primi anni Sessanta fino a due anni
fa, quando morì, sempre uguale a se stesso. O quasi. Certo,
l’accademico de Il
problema estetico in San Tommaso aveva
lasciato un po’ di spazio al mondano che si compiace di divulgare
in modo accattivante e divertente, ma rimaneva il monumento che era:
nessun bisogno di adattarsi a un ambiente che, pur cambiando, non gli
mai stato ostile, se non dargli lo sfizio di riacconciarlo per il
meglio – il suo meglio – con una svogliata abduzione del mignolo.
Provate a comparare Apocalittici
e integrati
che è del 1964 con Il
fascismo eterno
che è del 1997 (quella del 2018 per La
nave di Teseo
è solo una ristampa) e con la tirata contro i social della lectio
magistralis
tenuta a Torino nel 2015: stesso caleidoscopio espressivo, stessa
disinvoltura nel muoversi tra l’“alto” e il “basso”, stessa
padronanza degli espedienti retorici, stessa seduzione del lettore
nel volargli solo a un palmo sopra il naso per consentirgli di
acchiapparlo, di tanto in tanto, dandogli così l’illusione
d’essere un po’ più intelligente di quel che in effetti il lettore era. Poteva star
sul cazzo per un sacco di motivi, via, ma in fondo tutti futili e
tutti un po’ disonesti: era Umberto Eco – stop – e leggerlo
era un piacere, come lo è il rileggerlo ora.
Prendete, per esempio,
l’analisi di quel fenomeno eminentemente “nazional-popolare”
che era Mike
Bongiorno. Già, chi non ha letto Fenomenologia
di Mike Bongiorno?
Con l’odierno “populista”,
ovviamente, il parallelo risulta sghembo, ma, tutto sommato,
l’antecedente
storico era altrettanto cinico e violento, anche se aveva un tal
ritegno da apparire goffamente disarmato, al punto da poter perfino spacciare
un insulto come una innocente gaffe; fiero di quella supponenza che
ieri come oggi non ha neppure un centimetro quadrato su cui poggiare,
se non nella inscalfibile convinzione di sapere come gira il mondo;
convinto di essere irresistibilmente brillante anche nei più
eclatanti saggi di banalità; enciclopedia vivente del sentito dire e
del leggiucchiato qua e là; e qui mi fermo perché – dicevamo –
chi
non ha letto Fenomenologia
di Mike Bongiorno?
E sì, ma chi ha letto l’autodifesa di Mike Bongiorno al feroce
ritratto fattogli da Umberto Eco? La trovate ne La
versione di Mike (Mondadori,
2007 – pagg. 155-160). Non l’avete letta, vero? Lo immaginavo. È
che a voi il “populista”
fa schifo fin da quand’era
“nazional-popolare”.
Tanto schifo da ritenere inutile sentire le sue ragioni, che saranno
inconsistenti fin quanto vogliate, ma sulle quali ha potuto costruire
nei decenni la tracotanza con la quale ogni sera esce dallo schermo
televisivo per mettervi le zampe nel piatto. Lo faceva anche con
Lascia
o raddoppia?
e con Rischiatutto,
ma era assai meno evidente: sembrava un gattino, era divertente
lasciarvi usare come tiragraffi, ma è così che ha sviluppato gli
artigli. Ascoltando La
versione di Mike,
si possono fare i conti con le sue ragioni. Il che, se vogliamo dirci
onesti, è il minimo dovuto per capire com’è
che al governo è più facile trovarci chi partecipò a un quiz di
Mister
Allegria
che un “professorone”.
«[Umberto
Eco] stabilì
che ero diventato un uomo di successo perché rappresentavo
l’ignoranza delle grandi masse […]
[Scriveva:] “Mike
Bongiorno non si vergogna di essere ignorante e non prova il bisogno
di istruirsi”».
Obiezione: «L’accusa
[…] inizialmente mi ferì. […] Ma già allora sentivo che il mio
lavoro mi aveva portato a una conoscenza molto approfondita della
psicologia della gente».
L’ignoranza non è un problema quando ci si sente forte di una tal
dote, no? Soprattutto se a questa dote se ne sposa un’altra, e cioè
«la
capacità di trasformarmi davanti alla gente con la quale
interagivo»,
grazie alla quale può svilupparsi quella «sensibilità
che mi ha permesso di assorbire da ognuno certe caratteristiche umane
e di conoscere e di imparare con gioia le cose
[sic!] della
gente che ho incontrato, comprendendole con l’esperienza»:
è il primato della bettola sullo studiolo, in virtù del quale
Machiavelli avrebbe potuto
scrivere il suo Principe
anche rimanendo a ingaglioffirsi col beccaio, il mugnaio e i due
fornai, e chissà che forse il libricino poteva pure venirgli più
ganzo. A dispetto di questa “sensibilità”
che nasce dall’“esperienza”,
Mike
Bongiorno scivola nell’insulto
nel semplice dar forma di ovvietà agli stereotipi della
discriminazione e del più becero conformismo? Può darsi, ma «la
sincerità è una virtù».
«Molti
che hanno investito in arzigogolate forme di diplomazia politica lo
hanno spesso dimenticato»,
e che fine hanno fatto? D’altronde perché mettere in dubbio che la
sua “sincerità”
sia fedele specchio del reale? L’audience non lo prova?