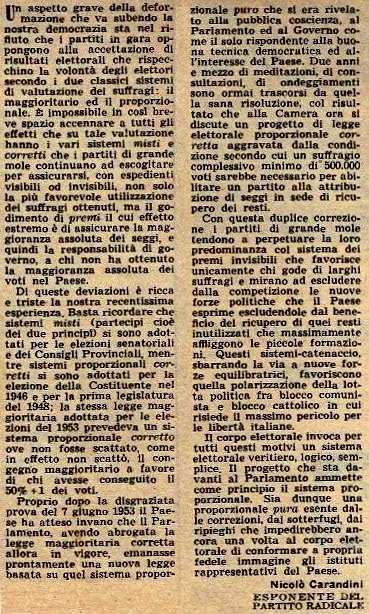Riproduco qui sotto una email inviatami da Nane Cantatore.
Credo che la posizione antispecista non stia in piedi per
una patente contraddizione logica, tanto grossa da renderla insostenibile: essa
infatti sostiene una continuità tra l’uomo e l’animale, a partire dalla comune
capacità di sentire e di soffrire. Lasciamo perdere l’evidente arbitrio per cui
proprio tale capacità dovrebbe essere fondativa di diritto, anche solo nella
limitatissima accezione del diritto a non provare sofferenza, e concentriamoci
sulla contraddizione, talmente grossa da essere, a mo’ di purloined letter,
invisibile: proprio tale condizione, tanto primaria da abolire ogni differenza
tra uomo e animale, sarebbe all’origine dell’imperativo etico, il quale
varrebbe però soltanto per l’uomo, appunto perché solo l’uomo è soggetto
morale. A riprova di tale affermazione, valga il fatto che i comportamenti
crudeli dei delfini, che stuprano e uccidono i cuccioli di focena e della loro
stessa specie, o dei leoni, la cui violenza intraspecifica è molto superiore a
quella umana, non vengono giudicati moralmente, salvo essere accusati, per l’appunto,
di antropocentrismo. In altre parole, l’identità tra uomo e animale sancirebbe
un dovere fondato sulla differenza tra uomo e animale.
Se questo approccio è insensato, non credo però che lo sia
la domanda a cui cerca di rispondere, e a cui credo siamo comunque chiamati
tutti a dare una risposta. La pongo nei termini con cui viene espressa in un
commento al suo secondo post:
“Prima di tutto dovrebbe spiegare perché non è
giusto provocare sofferenze agli animali?”
Perché se pensassimo che le sofferenze provocate agli
animali fossero un che di moralmente indifferente, il problema non si porrebbe,
e non solo per la sperimentazione ma per qualsiasi crudeltà. Invece, riteniamo
che tali sofferenze siano comunque un male, che può essere accettabile per un
bene maggiore (il topo sacrificato per la ricerca medica), e comunque da
limitare al massimo (il topo sia sedato, gli esperimenti effettuati solo quando
necessario e così via), ma non in tutti i casi (non, ad esempio, per la sperimentazione
di cosmetici). Si potrebbe porre la questione in termini puramente
quantitativi, come una contabilità della sofferenza accettabile per un dato
bene, ma tale risposta avrebbe innanzitutto il difetto di essere arbitraria e
imprecisa, tanto da faticare a immaginarla davvero dirimente: anche una volta
accettata la sperimentazione limitata e controllata, cosa fare dell’uccisione
di animali a scopo alimentare? E cosa fare, spostando l’asticella, dell’uccisione
di animali a scopo ludico? Perché, in altre parole, la bistecca sì e la corrida
no? Soprattutto, però, la questione resta: mentre è facile trovare dei motivi
razionali per vietare l’omicidio, il furto o la menzogna, è difficile giustificare,
una volta messa fuori causa l’empatia verso altri senzienti dalle motivazioni
razionali delle prescrizioni morali, l’immoralità, o comunque la connotazione
negativa, dell’infliggere sofferenza agli animali.
Per provare a rispondere, devo cercare di chiarire un
carattere fondamentale di ogni proposizione morale che abbia un senso: essa ha
un carattere necessariamente intersoggettivo, ossia passa per il riconoscimento
di un’alterità a cui si riconosce una validità o, per dirla in termini più
pregnanti, una dignità. È nei confronti di questo altro che sono moralmente
obbligato: in un mondo assolutamente solipsistico non ho obblighi, mentre già
nel paradossale universo idealista di Berkeley, o nei primi passaggi cartesiani
in cui ci sono soltanto l’ego cogitans e Dio, esiste per lo meno una matrice di
moralità.
Uscendo dalle iperboli metafisiche, la morale vincola
rispetto a soggetti reali e interagenti, a partire dal loro riconoscimento. Un
riconoscimento che non ha ancora, in questa fase, le caratteristiche della
reciprocità: quando il vincolo è reciproco, dalla morale si passa alla norma,
al diritto. Ma, e qui sta il punto cruciale, questa fase primigenia della
morale senza reciprocità, in cui l’altro non è coobligato insieme a me, è una
pura finzione filosofica: se devo agire verso altri secondo dei principi
conformi alla mia condizione rispetto a questi altri, o tale condizione è
fondata sul riconoscimento reciproco o i diritti che riconosco loro, in quanto
non danno luogo ad alcun obbligo intersoggettivo, sono semplici diritti
passivi, ossia concessioni, revocabili in qualsiasi momento, e un obbligo
revocabile e dipendente dalle circostanze o dalla volontà non è un obbligo morale.
Mi chiarisco: è chiaro che ogni ingiunzione morale può essere disattesa, ma il
suo valore resta a dispetto dei fatti; se, invece, tale ingiunzione non ha un
fondamento vincolante, ma riposa integralmente nella volontà, o nell’arbitrio,
di chi se la impone, allora essa perde il suo carattere imperativo. Insomma, la
morale è subito diritto, e credo che Hegel abbia ragione (anche) su questo.
Vorrei essere chiaro: nel definire imperativi gli obblighi
morali non intendo fare riferimento a dettami provenienti dall’alto di una rivelazione
o comunque legati a una qualche immutabilità ontologica o esistenziale (come mi
pare facciano gli antispecisti con la loro scaturigine dell’etica dal dato
ontologico della sensibilità), ma a un carattere formale della norma. Essa è
tale soltanto se ha un carattere generale o se riconduce comunque a esso, anche
quando tale carattere fosse nel criterio generalissimo della maggiore utilità
possibile per il maggior numero di individui, e tale carattere resta a dispetto
di ogni convenienza o contingenza che, semmai, concorre a determinare e a
specificare la norma.
Provo, finalmente, ad arrivare al punto: da quanto detto
finora, risulta che gli animali non possono essere soggetto di diritti, ma
soltanto oggetto di concessioni. Detto questo, vorrei però esaminare il
carattere del rapporto dell’uomo con gli animali, cercando di muovermi su un
terreno di continuità, proprio per recuperare un piano di reciprocità. Credo
che questo terreno sia quello dell’etologia e dell’ecologia, vale a dire della
struttura dei comportamenti all’interno di modelli non morali ma comunque
generatori di risposte complesse, vale a dire di significato, e delle
interazioni tra specie all’interno di uno stesso ambiente.
Ora, l’addomesticamento di numerose specie animali è
avvenuto su un piano di reciproca convenienza, ossia di simbiosi: le diverse
specie addomesticate hanno visto un netto incremento del loro successo
riproduttivo, della disponibilità di cibo e riparo, dell’estensione stessa del
loro habitat. L’uomo, a sua volta, ne ha ricavato a sua volta fonti di cibo più
variate, affidabili e abbondanti, oltre a tutta una serie di altri benefici per
attività che lo caratterizzano in modo peculiare rispetto agli altri animali,
dal vestirsi al guerreggiare. In altre parole, se l’uomo non si nutrisse
(anche) di bistecche, ci sarebbero molte meno mucche sul pianeta. Del resto, da
quando non si usa più la trazione animale, ci sono molti meno cavalli e asini:
l’introduzione dei veicoli a motore è stata, in questi termini, una catastrofe
ecologica per tali specie.
A queste condizioni, la sofferenza del singolo animale è,
dal punto di vista di questa economia simbiotica, accettabile nella misura in
cui essa fa parte delle condizioni del successo evolutivo di tale specie: il
maiale può essere macellato per farne salsicce, dal momento che le salsicce
sono la ragione per cui la specie del suino domestico è enormemente più
numerosa di quella del suino selvatico. È altrettanto chiaro che questa
sofferenza va tenuta al minimo necessario, dal momento che ogni specie, e ogni
individuo di ciascuna specie, ha il chiaro interesse a non soffrire. In questo
senso, il mutare delle condizioni reali può spostare il livello di sofferenza
accettabile: il cavallo di un carrettiere faceva una vita indubbiamente
peggiore di un cavallo da maneggio, ma in entrambi i casi la specie equina
godeva di un vantaggio simbiotico.
Fin qui, il tentativo di inquadrare la questione in senso
ecologico. Passando al versante etologico, ritroviamo l’intero universo di
relazioni e di empatia che osserviamo tra ogni animale, uomo ovviamente
compreso. Insomma, è palese il fatto di un reciproco investimento emotivo tra
uomo e animale, che avviene secondo forme di fatto codificate: si riconosce
quando un cane è amichevole, esistono segnali e comportamenti che possono
indurre alla tranquillità o all’aggressività mammiferi di specie diverse, e
così via. Si riscontra una notevole continuità nel comportamento umano e in
quello animale, e non sembra peregrina l’ipotesi che alcuni comportamenti degli
aggregati umani siano più simili a quelli dei canidi che degli altri primati,
fino a poter ritenere, come fanno diversi paleoantropologi, che alcuni
caratteri delle prime società umane siano stati fortemente informati dalla
presenza dei cani.
Ciò giustifica ampiamente la repulsione che proviamo verso
le sofferenze di altri esseri senzienti, e persino la legittimità di legiferare per il
loro massimo contenimento: infliggere sofferenze senza uno scopo è crudele, e
la crudeltà è repellente e socialmente distruttiva; di conseguenza, reprimiamo
la crudeltà. Detto per inciso (giuro, è l’ultimo inciso), questa proposizione
vale anche in una prospettiva morale di utilitarismo debole, ma ciò è dovuto al
fatto che l’utilitarismo debole (vale a dire, una prospettiva che non ponga la
massima utilitarista come imperativo morale, ma come semplice criterio
organizzativo) non è una dottrina morale, neanche intesa come morale “dal basso”.
Lo è invece l’utilitarismo forte (alla
Bentham), che, proprio perché si dota di una massima semplice e dotata di una
certa evidenza, è una dottrina morale abbastanza elegante ed efficace.
Allo stesso modo, limitare le sofferenze degli animali da
laboratorio o garantire buone condizioni di vita agli animali da allevamento
non è ipocrisia, come sarebbe se esistesse un imperativo morale a cui si
tributasse l’ossequio della forma per poi tradirlo nella sostanza, ma una
scelta dettata dalla nostra empatia animale e, a fortiori, umana; scelta che è
perfettamente funzionale all’economia simbiotica di cui sopra.
Da qui al diritto, però, c’è un abisso.