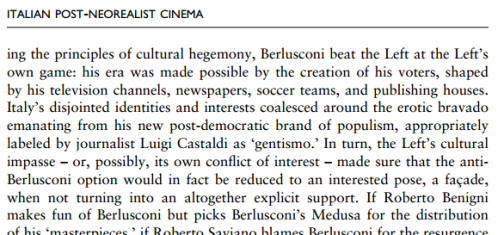domenica 4 marzo 2018
martedì 30 maggio 2017
Pippe
Wikipedia
gliene dà 35, ma Cerasa ha molti anni in meno, direi non più della
metà a giudicare dalle tante pippe che si fa. Grosse occhiaie, ma
poca fantasia, perché al ragazzo viene
duro solo con l’accoppiata
Renzi-Berlusconi: possibile,
probabile, immancabile, sicura, ci siamo quasi, ecco – e al culmine
del climax, avendo un debole per i classici – «ifix,
tchen tchen... ahhh!!!... sbozz!!!».
Si
sa com’è
la pubertà, possiamo chiudere un occhio, via. È evidente, tuttavia,
che la cosa può tornare d’imbarazzo.
Non tanto per Cerasa, che è giusto giunga ad una piena maturità
sessuale nel modo che più gli aggrada, seguendo l’indole: d’imbarazzo,
le sue pippe, possono tornare proprio a Renzi e a Berlusconi, che
potranno pure avere una gran voglia di farsene una,
e bella große,
ma prima delle elezioni sono tenuti a mantenere un minimo di contegno
e, dopo, a mostrarsi almeno un po’
ritrosi, quasi che a darci dentro, e di brutto, siano costretti, come a dire «non lo fo per piacer mio...». Un
po’
d’ipocrisia
piace tanto agli elettori del Partito Democratico e di Forza Italia,
rende più eccitante scoprire d’essere
fatti della stessa pasta.
Be’, non è difficile capire che le pippe di Cerasa facciano correre il rischio che l’incanto
si
guasti. Così, all’incauto
segaiolo è un maestro di buone maniere a dover dar consiglio.
lunedì 22 maggio 2017
[...]
Si
riapre la discussione sulla legge elettorale, che ora, dopo tanto
cincischiare, tutto tattico, parrebbe avere buone possibilità di
trovare i numeri in Parlamento, grazie a un’intesa
tra Partito Democratico e Forza Italia sulla base del comune accordo
di andare al voto subito dopo averne approvata una.
Sarà superfluo
rammentare che quattordici anni fa l’Italia
sottoscrisse il Codice
di buona condotta in materia elettorale
approvato dal Consiglio d’Europa, che nelle Linee
guida recita: «Gli
elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del
sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle
commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non
devono poter essere modificati nell’anno che precede l’elezione,
o dovrebbero essere legittimati a livello costituzionale o ad un
livello superiore a quello della legge ordinaria»
(II, 2, b).
Superfluo, perché richiamare le istituzioni italiane al
rispetto degli impegni presi in sede europea è inutile,
sarà per questo che fin qui a nessuno è venuto in mente di
sollevare la questione. A che serve, dunque, rammentarlo? È presto
detto: serve a prendere in considerazione le possibili critiche al
richiamo. Due sono quelle largamente prevedibili.
C’è
chi dirà che alla scadenza naturale della legislatura, in primavera,
non sarebbe comunque passato un anno dall’approvazione
di una legge elettorale che comunque non potrà vedere luce prima di
giugno: non si può mica rimandare il voto.
Certo, non si può, ci
mancherebbe altro. È per questo che una legge elettorale sarebbe
stato meglio approvarla prima. Di fatto, tuttavia, il succitato punto
del Codice di buona condotta
elettorale ha una ragion
d’essere,
che trova spiegazione Rapporto
esplicativo in allegato alle
Linee guida:
«La stabilità del
diritto è un elemento importante per la credibilità di un processo
elettorale, ed è essa stessa essenziale al consolidamento della
democrazia. Infatti, se le norme cambiano spesso, l’elettore
può essere disorientato e non capirle, specialmente se presentano un
carattere complesso» (63).
Ne
consegue che, quanto più tempo passa dall’approvazione
di una nuova legge elettorale al voto che per la prima volta la vedrà
applicata, meglio è: meglio otto mesi che otto settimane per capirci
qualcosa. Conterà ancora qualcosa, la libera formazione della
volontà dell’elettore?
E come si può assicurargliela senza un’adeguata
informazione relativa allo strumento attraverso il quale la sua
volontà sarà espressa?
La
seconda critica raccoglie questa controbiezione, e in buona parte la
supera, anche se con due possibili argomentazioni: (a) la materia
elettorale è di ardua comprensione alla gran parte degli elettori:
neanche otto anni basterebbero per spiegare la ratio di una legge
elettorale a un terzo degli aventi diritti al voto; (b) la democrazia
borghese è una truffa, pensare che un’adeguata
informazione sulla legge elettorale serva a rendere l’elettore
più libero e più responsabile significa di fatto rendere più
sofisticata la truffa, non smascherarla.
Sebbene siano di segno
opposto, le due argomentazioni hanno in comune un presupposto: le
elezioni sono inutili, e in egual misura, sia a un popolo che (a') è
inemendabilmente bue, sia a quello che (b') troverà risposta ai suoi
bisogni solo con l’abbattimento
dello stato borghese.
E qui mi arrendo.
domenica 21 maggio 2017
Vittima di una congiura
«Una
grave patologia caratteriale del leader,
come un narcisismo
patologico complicato da
aspetti paranoidi, potrebbe dimostrarsi
disastrosa»
Otto Kernberg, 1998
Pure la paranoia, adesso, e proprio in ciò che ne è patognomonico: Matteo Renzi si sente vittima di un complotto e, giacché il suo narcisismo lo fa sentire istituzione («l’état, c’est moi»), dice che si tratta di eversione. Anche in questo segue le orme di Silvio Berlusconi, si dirà, e questo è vero, ma con ciò possiamo ritenere chiusa la questione? Non ci torna utile cercare di capire quali siano le precondizioni personali e di contesto che fanno da piano inclinato lungo il quale questi infelici rotolano nell’abisso, spesso trascinandosi dietro proprio quanti gli hanno dato peso e abbrivio?
Occorre essere onesti: ci mettono del loro, senza dubbio,
ma è nello stesso essere leader che s’annida la potenziale
regressione. Naturalmente si può dirlo meglio.
Quando
queste pressioni vengono ad agire su un soggetto con un serio
disturbo della personalità come quello narcisistico, si realizza un
quadro che dovremmo saper riconoscere anche se a digiuno di
psichiatria. Ridò la parola a chi lo descrive assai meglio di quanto
potrei farlo io, invitando il lettore a leggerlo come un identikit.
Rimanda
alla mente qualcuno in particolare? Forse potrà aiutare la
descrizione dell’habitat
relazionale in cui tizi del genere s’imbozzolano:
costituisce il modulo-base attorno al quale viene a svilupparsi la
costruzione paranoica.
Qual è
il passaggio successivo nella costruzione paranoica del complotto?
Per meglio dire: cosa è necessario accada perché questa abbia
ragione di essere costruita? Potrà sembrare banale, ma è necessario
accada che il leader si senta in pericolo. E il maggior pericolo è
dato da una ferita al suo narcisismo: una sconfitta, un’umiliazione,
una perdita di posizione, un’incrinatura nella convinzione di
essere invulnerabile.
Nel
caso di Matteo Renzi, dalla sconfitta del 4 dicembre al caso Consip,
tutto ha concorso in tal senso. E ora eccolo a sentirsi vittima di
una congiura: ottima fuga dalla realtà, ottimo riparo dalle
responsabilità.
venerdì 19 maggio 2017
Gentismo vs populismo
La prima reazione a questo annuncio potrebbe essere a buon diritto di forte perplessità, se non di franco disorientamento: cos’è, il berlusconismo, se non un populismo? Con quale faccia tosta, dunque, si atteggia ad antipopulista, oggi, Berlusconi?
Ad una più serena considerazione, tuttavia, occorre considerare lo specifico del populismo che abbiamo visto all’opera dal 1994 al 2011: un populismo che aveva tutti i tratti del populismo (demagogia, velleitarismo, rapporto fusionale tra leader carismatico e base di consenso, una qual certa dose di avventurismo, ecc.), ma al quale Berlusconi aveva dato un carattere piccolo-borghese, levandogli quanto di socialistoide c’è sempre stato in ogni populismo.
Berlusconi, infatti, non si rivolgeva a cittadini affamati di egualitarismo, ma a contribuenti-consumatori-spettatori cui prometteva un modello di società nella quale le disparità tra individuo e individuo fossero da intendere come forme attive, insieme plastiche e dinamiche, della loro «libertà».
Finalmente liberata dai «lacci e lacciuoli» dello «statalismo» di stampo «cattocomunista» della Prima Repubblica (il lettore perdoni la profusione di virgolettati: ogni populismo ha il suo idioletto, quello di Berlusconi si limitava a una ridefinizione di termini comuni, non di rado ambigui, spesso consunti da un lungo uso), la società italiana sarebbe diventata un Paradiso, del tipo che Piccarda Donati spiega a Dante, stupito che la beatitudine abbia gerarchia per cerchi: tutti felici, nella promessa di Berlusconi, per essere ricolmi di benessere secondo le proprie diverse capacità, dando a capacità la doppia accezione di abilità e capienza (abbondanza di pietanze ai più agiati, abbondanza di avanzi al ceto medio, abbondanza di briciole ai più bisognosi).
Direi ci fosse il quid e il quantum per dare un termine adeguato a questo populismo, e l’insistente richiamo alla «gente» piuttosto che al «popolo» cosa suggeriva? «Gentismo» calzava come un guanto.
Non sono stato certo io a coniare il termine «gentismo»: esisteva già da parecchio tempo prima ch’io cominciassi a usarlo (la prima volta, in una lettera che Il Riformista di Antonio Polito mi pubblicò nel 2004; poi, su queste pagine, soprattutto tra il 2007 e il 2009), conscio che già esistesse, ma senza essere in grado di precisare donde venisse. Ancora oggi non saprei dire dove io l’abbia incontrato per la prima volta, visto che Google mi dà solo tre voci antecedenti al 2004 (l’Enciclopedia delle scienze sociali della Treccani, dall’edizione del 1996 in poi, alla voce Populismo; un corsivo di Michele Serra del 2002; un pamphlet di Davide Giacalone del 2003), dalle quali sono comunque sicuro di non averlo potuto attingere.
Non sarebbe neanche necessario precisare di non aver coniato io il termine, perché Luca scrive che mi sarei limitato ad appiccicarlo come etichetta al «new post-democratic brand of populism» incarnato da Berlusconi, ma quell’«appropriately» mi pare crei confusione conferendomi un merito che non potrei comunque vantare, visto che il «labeling» era già in tutte e tre le fonti sopra citate. Cosa può averlo tratto in inganno, sebbene io non abbia mai millantato questo merito, né su queste pagine, né altrove?
Posso solo avanzare un’ipotesi. Con lui, qualche anno prima della pubblicazione del suo peraltro splendido lavoro, ebbi uno scambio epistolare che non rammento più come ebbe inizio, ma che spaziò di lungo in largo, da Pasolini a Deleuze, da De Sica a Tangentopoli, da Monicelli a Bossi. Chiacchiere in libertà, e lì dentro sarà finito inevitabilmente quello che scrivevo su queste pagine: a Luca sarà parso che le mie riflessioni fossero particolarmente originali, e che la disinvoltura con la quale usavo un termine come «gentismo» facesse indizio di esserne altrettanto originale formula riassuntiva.
Mistero fitto, invece, su come Luca possa aver pensato io fossi un «journalist», perché non lo sono, né ho mai desiderato esserlo, né mai avrei potuto darlo da credere, tenuto conto della pessima considerazione in cui ho sempre tenuto il giornalismo e i giornalisti. Credo si tratti di un lavoro duro e mal pagato, che dia pochissime soddisfazioni e imponga regole alle quali non sarei assolutamente in grado di piegarmi. Più in generale, ritengo che la scrittura abbia molto in comune col sesso: farlo a pagamento, anche quando non si ha voglia, cercando di accontentare il cliente e di non fare incazzare il pappone, semmai fingendo pure l’orgasmo, mi pare un incubo, e non faccio differenza tra escort di lusso e infima bagascia, perché ho avuto l’opportunità di conoscere professionisti del settore assai stimati dall’opinione pubblica, ma anch’essi non mi son parsi venir meno alla legge che il lettore vada ingannevolmente compiaciuto, secondo le sue voglie, fra le quali può ben esserci quella di essere maltrattato un poco. Direi che ogni giornalista sia un populista in sedicesimo.
lunedì 15 maggio 2017
[...]
L’amministratore
delegato di una banca che ha più di 40 milioni di clienti in 22
paesi può essere completamente a digiuno dell’abc della
comunicazione? Ti chiedono di confermare o smentire quello che un
giornalista dice di aver saputo da te, e come te ne esci? Con un «no
comment». Evidentemente ignori quello che spiegano gli esperti
del settore: quella risposta «can sound like you are responsible,
like you are hiding facts, or withholding information. [...] may give
the impression you really are in trouble or you might suddenly
created trouble when none existed before [...] you’ve
created a controversial answer right when you’d
probably prefer to avoid controversy» (Ian Taylor & Georges
Olds, Never Say «No Comment»). O forse no, tutto questo lo
sai. Vuoi confermare senza confermare.
sabato 13 maggio 2017
«Né di destra, né di sinistra»
Con un orgoglio, che sotto la maschera di una innocente e vulnerabilissima modestia riesce a celare anche abbastanza bene tutta la sua smisurata tronfiaggine, sentiamo sempre più spesso rivendicare l’essere «né di destra, né di sinistra». È il caso, per esempio, dei grillini più in vista (Di Maio e Di Battista, soprattutto), oltre che dello stesso Grillo, che, col definire il M5S «né di destra, né di sinistra», pare siano convinti di aver trovato il più comodo espediente per poterlo spostare, con estrema rapidità, ora a destra, ora a sinistra, secondo come butta l’umore della platea della quale aspirano ad ottenere il consenso: «né di destra, né di sinistra», dunque, per poter essere oggi di destra, domani di sinistra, dopodomani ancora di destra, e così via.
Il dirsi «né di destra,
né di sinistra», invece, raramente è della base militante
grillina, tanto meno dell’elettorato che vota il M5S: l’una e
l’altro, infatti, almeno per il residuale habitus etico-estetico
che si trascinano dietro dal loro personale passato, sono in parte di destra, in
parte di sinistra e in parte anche di quel centro incline a un
qualunquismo placido, quando le vacche sono grasse, e anche parecchio esagitato, ma più urlereccio che manesco, quando le vacche
sono magre.
L’antecedente
storico più remoto di questo dirsi «né di destra, né di sinistra»
è infatti proprio il qualunquismo di Giannini, ma occorre rammentare
che prima del M5S fu la Lega di Bossi a farlo proprio, e con
un’enfasi
d’accento
che, al pari di quanto è dato rilevare con Grillo e i suoi, tendeva
a fare dell’esser
«né di destra, né di sinistra» una parodia del «metapolitico»
(Bossi, 1992: «Non siamo né “di destra”, né “di sinistra”,
ma “al di sopra”»), che ancora dà una stanca eco in certe
odierne tirate di Salvini.
Ora e allora, un «né di destra, né di
sinistra» che significa di una destra così ignorante da non
sentire più bisogno neppure del più usato armamentario retorico
della destra: una destra cui per unica fierezza basta il
becerume.
Alla
maschera della modestia, però, talvolta si sostituisce quella della
responsabilità, sotto la quale si riesce a scorgere una tronfiaggine
che si concede pure il lusso del sussiego, e che della formula «né
di destra, né di sinistra» non fa una scelta, ma una necessità.
«Né di destra, né di sinistra» – si argomenta – sono i
problemi. «Né di destra, né di sinistra», dunque, hanno
necessariamente da essere le soluzioni, salvo intestardirsi a voler
inscrivere gli uni e le altre in una costruzione ideologica, che alla
coerenza, virtù dei fessi in un mondo che va così veloce, sacrifica
lo starci coi piedi ben piantati sopra.
È il caso, questo, del Pd di
Renzi, ma – attenzione – non dello stesso Renzi, che anzi insiste
nel ribadire che sotto la sua guida il partito resta un partito di
sinistra, a dispetto di tutto ciò che inoppugnabilmente prova
l’esatto contrario. Così, nel mentre chi è salito sul carro di
Renzi tre o quattro anni fa ancora si affatica inutilmente nel
tentativo di convincerci che il Jobs Act sarebbe una riforma di
sinistra, tra i renziani nativi fa capolino un fiero orgoglio di
dichiararsi «né di destra, né di sinistra» che, con la grazia con
la quale il vizio fa omaggio alla virtù, indugia in un’ultima
reticenza.
E così parla uno dei «20 giovani portati da Renzi nella
direzione del Pd» (Il Foglio, 11.5.2017): «La sinistra indicava
socialdemocrazia, welfare, ridistribuzione del reddito,
partecipazione del “popolo” al governo delle cose, sia in
politica, sia nel lavoro. La parola sinistra aveva un forte contenuto
politico, era una distinzione riconoscibile anche sul piano
valoriale. Il concetto di sinistra si è ovviamente evoluto nel
tempo, senza però perdere quei valori che la contraddistinguevano.
Oggi il compito della sinistra è di ridefinire una politica di
cambiamento. Le soluzioni non si collocano più a un preciso punto
della scala che va da destra a sinistra. Urgente è il fare.
Rivolgersi ai problemi. Riparare una buca è di destra o di
sinistra?».
Il
concetto di sinistra si è evoluto, questo è evidente. Tanto evoluto che oggi la soluzione di un problema sembra non abbia niente a che fare col modo in cui il problema è posto, sicché «politica di cambiamento» sta in realtà per «cambiamento di politica». Nel fare per fare, e nel farlo
in fretta, cosa conta più un preciso punto della scala che va da
destra a sinistra?
venerdì 12 maggio 2017
Ditemi, poi
Bisogna
capirlo, il Gramellini, ha perso la mamma da bambino, ha riempito il
vuoto col fantasma di un angelo, eppoi è Bilancia, quindi è
inevitabile galleggi in una bolla di sentimentalismo impermeabile
alla realtà, una di quelle bolle nelle quali entrano solo donne
angelicabili, mica nessuna di quelle fameliche arpie che, oltre ad essere la
schifezza della schifezza di mogli e la schifezza della schifezza di
madri, son buone solo a fare shopping e depilazioni.
Dice: vabbè,
però ha affrontato pure lui un divorzio, quindi è da elogiare se
scrive quel che scrive all’indomani
di una sentenza della Cassazione che allenta un poco la garrota
attorno al collo di un poveraccio costretto dalle leggi dello Stato a
pagare il pizzo a vita a una tizia verso la quale l’unico
pensiero cui ti lega, e solo una volta al mese, è quello di sperare
che un cancro prima o poi le divori il colon, e manco tanto per
cattiveria, ché dopo tanti anni dalla separazione potrebbe perfino
farti un po’ pena, ma per poter essere finalmente liberato dall’imposta
sulla cazzata fatta tanto tempo addietro.
Calma, calma, ché
Gramellini ha affrontato, sì, un divorzio, ma la cosa deve averlo
appena sfiorato. La moglie era la Rodotà – per intenderci, quella
che in seconde nozze poi ha sposato la Mastrobuoni, chissà, forse
generalizzando un po’ troppo –
e a quei tempi la Rodotà era già più che indipendente sul piano economico, non è nemmeno
escluso che il giudice abbia deciso che lei dovesse pagare gli
alimenti al Gramellini, che a quei tempi, prima di imboccare il
fortunato filone della posta del cuore, da giornalista si distingueva
solo per l’aspetto da peluche uscito da
una lavatrice, peraltro dopo un lavaggio dal programma sbagliato.
Volevo
mandargli un «va’
a cagare» via Twitter, al Gramellini, ma tutto questo mi ha fatto
chiudere un occhio. Ditemi, poi, se sono o no uno che, prima di partire in quarta, sa mettersi nei panni altrui, comprendere, chiudere un occhio, far finta di niente.
martedì 9 maggio 2017
Troppo francese
Dopo
aver donato al mondo mille e mille novità in campo artistico, un
secolo fa venne il momento del fascismo, che nel Dizionario di
politica edito a cura del Partito Nazionale Fascista nel 1940
(quattro volumi, 2.875 pagine, 1.079 voci) viene costantemente
definito – giustappunto – «arte»
(«di governo»).
Fu così che, ancora una volta, l’Italia
si confermò fucina di cose mai viste, laboratorio di invenzioni
originalissime, che immancabilmente ci vengono invidiate, prima, e
copiate, poi.
Così era accaduto con Brunelleschi, Leonardo,
Raffaello, Michelangelo, e così accadde con Mussolini: la creazione
ebbe immediato successo e, con gli aggiustamenti necessari per
adattarla al gusto del pubblico cui era offerta, fu replicata in ogni
dove. Spesso acquistava tratti che solo in apparenza la rendevano
diversa, e anche molto diversa, dall’originale,
ma ad un’attenta analisi era
evidente, e sempre, l’inconfondibile
cifra dell’italianità, quel
nostro essere capaci di trasformar lo stucco in marmo, e il marmo in
carne viva, di dare alla piatta superficie della tela la pressoché
tangibile profondità di una prospettiva, di conferire alla posa
immobile del gesto la sensibile essenza di un movimento. Raramente
fummo superati e, quand’anche
sembrò fosse accaduto, fu chiaro che nel superarci qualcosa del
genio era andato perduto, quasi che per andar oltre si fosse rotto
l’intrinseco equilibrio tra
mezzo e fine, con l’irrimediabile
perdita di una conclusa armonia.
Il nazismo, per esempio. Agli occhi
di Hitler, Mussolini era un genio insuperabile, e tuttavia cercò di superarlo. In un certo senso
poté sembrare ci riuscisse pure. Ma cosa diventò, il fascismo, in
Germania? Perse la calda esuberanza dello zotico teppista di Strapaese
per acquistare l’algida
brutalità dello sventrapapere seriale della Bassa Baviera: stessa
differenza tra un Guarneri del Gesù e un Yamaha YVN50, via. Diciamolo con orgoglio: il quid italiano è inimitabile.
Perciò
andiamoci piano col mettere sullo stesso piano Renzi e Macron:
giovane età, ascesa fulminante, indubbio culo, cinico opportunismo,
rottura dei paradigmi della vecchia politica – tutto quello che
volete – ma il primo è bestia fatta, il secondo non ancora, e
chissà se lo sarà mai. Troppo francese.
Una pagina di Avvenire
Un
«dibattito»
– prendo la definizione che ne dà il De
Mauro –
dovrebbe essere una «discussione
di più persone nella quale le diverse opinioni vengono discusse e
vagliate».
Avvenire
parte male fin dall’occhiello,
dunque, nel presentare come «dibattito»
i tre interventi pubblicati a pag. 3 del numero in edicola martedì 9
maggio, perché questi non esprimono affatto «opinioni
diverse»:
Lucio Romano (Disposizioni
o dichiarazioni: la differenza è di sostanza),
Gian Luigi Gigli (Ridurre
la portata negativa di una legge nata male)
e Carmelo Leotta (Se
un pm afferma che una vita vale meno)
hanno un dichiarato idem
sentire
sulle tematiche relative al «fine
vita»
e a tutti e tre non vanno affatto bene le
Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento
approvate alla Camera lo scorso 20 aprile.
Più che un «dibattito»,
insomma, Avvenire
manda in pagina un monologo a tre voci, e a tanto, già di per sé
irritante, aggiunge il carico, francamente insopportabile, di dar
conto delle possibili «opinioni
diverse» unicamente
attraverso l’infedele
esposizione
che ne fanno i tre prestigiosi avanzi di sagrestia chiamati a intervenire sul
tema.
Un modo molto disonesto di procedere, perché neppure il fatto di
essere un organo di partito – cos’altro
è, la Cei? – solleva Avvenire
dall’obbligo
di dare una corretta informazione ai suoi lettori. Ma veniamo al
merito.
«Le
disposizioni anticipate di trattamento –
scrive Lucio Romano – si
rappresentano come estensione nel tempo di un consenso informato
anticipato [ma]
solo ad una lettura generica […] possono essere assimilate al
consenso informato, [che]
è accettazione libera, cosciente, attuale, revocabile e consapevole
del paziente a sottoporsi ad un atto medico, con una informazione
preliminare, adeguata e specifica, circa benefici, rischi,
complicanze correlate o prevedibili».
Bene, tutto questo verrebbe meno col concedere ad un individuo il
diritto di decidere per tempo sul proprio «fine
vita»,
perché «le
“disposizioni” esprimono volontà vincolanti da seguire quando
non più in grado di esprimersi».
In più, «non
sono assimilabili al consenso informato perché, seppur stabilite in
libertà e consapevolezza, non potranno essere mai attuali perché
redatte “ora per allora”; dovranno essere prevalentemente
generiche non potendo definire lo specifico; non sono informate in
quanto formulate prima dell’insorgere della patologia, senza
conoscenza di circostanze e modalità; non potranno essere più
revocabili in situazione di irrecuperabile incapacità di intendere e
di volere».
La natura capziosa di quest’argomentazione
si rivela al solo controbattere che in questione è quello che
comunemente è detto «biotestamento»,
e cioè un testamento relativo alla vita, inteso come bene personale
del quale è lecito disporre come meglio di creda. Superfluo rammentare che, al pari di ogni testamento, anche quello relativo al «fine vita» può avere revisioni senza limiti.
Accogliendo le
obiezioni di Lucio Romano, non dovrebbe esserci permesso di far
testamento su alcun bene di nostra proprietà. Non dovremmo forse
ritenere valide le disposizioni di quanti hanno lasciato i loro averi
alla Chiesa? Certo, hanno deciso in libertà e consapevolezza, ma il
loro testamento fu redatto “ora
per allora”,
senza poter essere più revocabile in situazione di irrecuperabile
incapacità di intendere e di volere. Dovremmo ritenere nulle, perché
illegittime, quelle disposizioni? Lo Stato dovrebbe procedere alla
confisca di tutti quei beni che nel corso dei secoli tanti privati
cittadini hanno lasciato alla Chiesa?
La fin troppo prevedibile
controbiezione a questa che in realtà – confesso – è una
provocazione (voleva provocare proprio una controbiezione del genere) è la
seguente: la vita non è un bene di cui si possa liberamente
disporre. Bene, ma allora, prima di contestare la legittimità di
quanto viene concesso al cittadino nelle Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento,
si chieda al Parlamento di approvare una legge che sanzioni il
tentato suicidio, anche quando non sia assistito. Per il suicida che
riesca nel suo intento, infatti, sarà impossibile procedere (ci penserà Dio
a ficcarlo nel girone dei violenti verso se stessi), ma a chi
fallisce spetterebbe una pena, e severa. Vedete a cosa costringe, uno
come Lucio Romano? A prenderlo sul serio, e con quanto ne consegue.
E
già accaduto, perché l’ho
conosciuto personalmente. Era un assistente nel reparto di Ostetricia
e Ginecologia dove io facevo il praticantato di specializzando, e un
giorno mi chiese di procurargli qualche immagine ecografica di
embrione alla sesta o settima settimana di gestazione, ne doveva ricavare delle diapositive per i sermoni pro-life che a quei tempi –
parlo degli anni a cavallo dei Settanta e degli Ottanta del secolo
scorso – teneva per conto di Carlo Casini, l’allora
presidente del Movimento
per la vita.
Quando gliene diedi una mezza dozzina, le guardò deluso: «Non
si poteva far di meglio? Sembrano solo fagiolini». Gli risposi:
«Quello sono, Lucio, tutto il resto spetta all’immaginazione».
Ma divagavo, torniamo alla pagina di Avvenire.
Il
secondo intervento, a firma di Gian Luigi Gigli, che di Carlo Casini
ha preso il posto, mira a reclutare forze per impedire che la legge
approvata alla Camera superi il vaglio del Senato.
«È
giunto il momento –
scrive – di
chiedersi se c’era davvero bisogno di una simile legge». [Invece di «c’era»,
forse, andava meglio «ci
fosse»,
ma possiamo chiudere un occhio, perché Gigli non è un grillino.] La
risposta? «Certamente
no, se l’intenzione era di evitare situazioni di ostinazione
terapeutica. La medicina ha superato ogni tentazione in tal senso e,
se non fosse bastato, le esigenze di controllo della spesa sanitaria
e l’intervento degli ordini dei medici avrebbero potuto dissuadere
qualunque nostalgia di accanimento».
Un brivido di orrore ci corre lungo tutto il rachide: sono le
esigenze di controllo della spesa sanitaria tra i motivi a dissuadere
dall’accanimento?
Ma poi: chi potrebbe averne nostalgia? Insomma: chi è il nostalgico
dell’accanimento
terapeutico che si piega dinanzi a basse ragioni di natura economica
quando è in gioco la vita, peraltro inteso come bene indisponibile a chi ne è titolare? La sensazione è che sarebbe difficile
poter avere una risposta, quindi procediamo.
Inutile, la legge, «se
si voleva garantire la possibilità di rifiutare l’avvio di
trattamenti non desiderati. La redazione del consenso informato è
obbligatoria negli ospedali e un medico non potrebbe imporre
trattamenti senza ricorrere all’intervento dei carabinieri ed
esponendosi a rischi e rivendicazioni».
Certo, ma il concetto di «consenso
informato»
si è storicamente affermato a partire dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
(1948), che la Santa Sede si è sempre rifiutata di riconoscere
proprio per quanto in esse vi è affermato relativamente alla
«libertà
della propria persona»
(art. 3).
Va inoltre rammentato che il Catechismo
della Chiesa Cattolica recita
che, «anche
se la morte è considerata imminente, le cure che d’ordinario
sono dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente
interrotte»
(2279). È questo, infatti, il punto di caduta dell’argomentazione
di Gigli, per il quale «obiettivo
reale [della
legge sul biotestamento] era
evidentemente un altro: permettere l’interruzione di qualunque
trattamento»,
con
riferimento alle «cure
che [il
Catechismo ritiene] d’ordinario
dovute»,
come si esplicita col dire «assurdo»
che una legge definisca «terapie»
l’idratazione e la nutrizione assistite, «per
renderle rifiutabili in qualunque momento».
E qui siamo di nuovo costretti alla provocazione. Sembrerebbe,
infatti, che non si voglia tener conto di cosa esattamente si intenda
per idratazione e nutrizione assistite. Perché queste possano essere
messe in atto, occorre personale medico qualificato, con
l’espletamento
di procedure relativamente complicate, e per mezzo di strumenti che
sono propriamente clinici: come ci si può azzardare a non
considerarle «terapie»?
Parliamo di tubi e siringhe, non di acqua e pane. E perché un malato
non avrebbe il diritto di rifiutare un sondino nasogastrico, se poi
può rifiutare una qualsiasi infusione che anche lo stesso Gigli
sarebbe disposto a concedere costituisca «accanimento
terapeutico»?
Col
terzo intervento mandato in pagina da Avvenire
possiamo cavarcela più brevemente.
Carmelo Leotta se la prende col
pm che ha fatto domanda di archiviazione per Marco Cappato,
autodenunciatosi per aver accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera,
aiutandolo in tal modo ad esaudire la sua volontà di procedere ad un
suicidio assistito, e scrive che «l’articolo
580 parla chiaro e stabilisce che “chiunque determina altrui al
suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne
agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio
avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni”»,
mentre invece nelle motivazioni alla richiesta di archiviazione viene
affermato un «principio
di dignità [che] impone l’attribuzione a tutti coloro che vivono
in condizioni gravissime o irreversibili, percepite dal malato come
lesive del senso della propria dignità, “di un vero e proprio
diritto al suicidio”, esigibile non solo in via indiretta con la
rinunzia alla terapia ma anche in via diretta, con l’assunzione di
una “terapia finalizzata allo scopo suicidario”»,
e questo gli pare scandaloso, perché così si affermerebbe una grave
disparità di diritti, che in apparenza sarebbe in favore del
soggetto ammalato
e a scapito del soggetto sano, ma che in realtà farebbe passare il
principio che «la
vita del malato “vale” meno della vita del sano, visto che il
primo ne può disporre, e il secondo no».
L’eleganza con la quale ci è presentato il sofisma non ci consente
di liquidare anche qui l’argomentazione con una provocazione.
Verrebbe, sì, di tagliar corto obiettando che, tanto per fare un esempio,
anche nel caso della legittima difesa una vita (quella
dell’aggressore) finisce col “valere”
meno di un’altra (quella dell’aggredito), ma che al momento il Codice
Penale
(art. 52) continua a contemplarla come «legittima»,
così consumando quella che per Leotta sarebbe «una
insanabile violazione del principio di uguaglianza». Verrebbe da esortarlo a portare l’art. 52 dinanzi alla Consulta, e subito, perché lì dentro passa un’intollerabile differenza di “valore”
che
ci sarebbe tra vita e vita. Verrebbe, ma rinunciamo.
Lasciamo che dinanzi alla Consulta vengano portati gli artt.
579 (Omicidio
del consenziente)
e 580 (Istigazione
o aiuto al suicidio),
ma poi non mettiamo cruccio al musetto se saranno dichiarati
incostituzionali sulla base delle stesse motivazioni che il pm ha
addotto in favore dell’archiviazione. Se ci si appella alla legge
degli uomini, non sempre si ha risposta illuminata dalla legge di Dio. E siamo sicuri che Leotta non abbia bisogno di esempi.
giovedì 4 maggio 2017
[...]
Con
le modifiche che la Camera dei Deputati apporta all’art.
52 del Codice Penale («Difesa
legittima»),
viene accolto l’emendamento
che inserisce dopo il primo comma il seguente testo: «Si
considera legittima difesa, nei casi di cui all’art. 614
,
primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in
tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei
luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con
minaccia o con inganno».
Non ha alcun fondamento, dunque, quanto lascia intendere Matteo
Salvini scrivendo: «Legittima
difesa, per il PD un cittadino si può difendere se è “aggredito
di notte”. Quindi di mattina e pomeriggio tutto è lecito?». Né ha ragion d’essere quanto ha affermato Silvio Berlusconi, che di rincalzo ha parlato di una «norma troppo blanda».
Niente affatto, inemendabili teste di cazzo, perché con la riforma dell’art.
52 si
considera legittima difesa non solo «la
reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte»,
ma anche quella «a
seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle
persone o alle cose»,
e senza alcuna restrizione relativa all’ora
del giorno in cui questo accada, né contemplando eccezione di sorta in
favore di chi «s’introduce
nell’abitazione
altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze
di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s’introduce
clandestinamente o con inganno»
(art.
614). E che volete di più?
martedì 2 maggio 2017
[...]
Dieci
anni fa andava in onda la prima puntata di Boris, una delle più
riuscite allegorie dell’Italia
d’oggi.
Anche chi abitualmente ha in uggia gli anniversari non può fare a
meno di celebrare un evento che da mera ricreazione si eleva a
riflessione fenomenologica.
Uno stronzo a forma di serpente, sì, ma non solo
Si
trattasse solo della sua parabola umana, potremmo anche fare a meno
di occuparcene, perché quella di Matteo Renzi è del genere che non
offre alcun interesse particolare. Noto il fuoco, nota la direttrice,
nota la formula che ne genera la curva, noti i valori che ne
determinano il profilo, quale che sia il piano sul quale possiamo
andare a considerarla come percorso personale, apologo morale o caso
clinico, è parabola che sappiamo come sale e che sappiamo come
scende. Lungo tutta la salita, d’altronde,
abbiamo visto confermati tutti i caratteri di questo genere di curva,
mentre dal 4 dicembre ad oggi, in questo primo tratto di discesa, ne
abbiamo puntualmente avuto il riscontro atteso.
Potremmo,
insomma, lasciar perdere Matteo Renzi, dedicandoci a questioni più
interessanti, per limitarci a metterci una pietra sopra quando tra tre o quattro anni sarà tornato da dov’era
partito, ma coperto di merda. E
invece occorre occuparcene, perché alla sua parabola umana sembra
ormai indissolubilmente legata quella di una parte del paese.
A
scanso di equivoci, però, chiariamo: Matteo Renzi non nasce dal
nulla per legare indissolubilmente a sé il Pd con chissà quale
fatale e subdolo sortilegio. Senza voler affatto sottovalutare gli
strumenti che gli hanno permesso di trasformarlo in un partito
personale, è il caso di aprire gli occhi su ciò che il Pd era fin
dalla sua nascita, e che spesso pare sia rimosso, per piegare alla
vulgata della «mutazione
genetica»
che un post-democristiano avrebbe indotto in un partito che al
momento della fondazione era almeno per tre quarti post-comunista.
Il
rimosso è che, almeno in nuce, il Pci aveva, fin dal 1975, acquisito
i tratti di quel partito socialista borghese (cfr. Gian Franco Venè,
La
borghesia comunista,
SugarCo 1976), che «corrisponde
al suo proprio carattere solo quando diventa pura figura retorica»
(Karl Marx/Friedrich Engels, Il
manifesto del partito comunista,
3, 2). Di questa figura retorica del socialismo era riuscito a
conservare i tratti fin dopo la Svolta della Bolognina, quando,
peraltro senza alcuna elaborazione critica del suo più prossimo e
recente passato, cominciava a dirsi socialdemocratico, per diventare
sempre più solido cooperante della trasformazione cui intanto il
capitale andava incontro, a fronte del processo di globalizzazione
del mercato. Restava solo la blairizzazione del partito in cui il
Pci-Pds-Ds andava a confluire, per dare pienamente conto delle
politiche sempre meno «di
sinistra»
del Pd, e
tuttavia rivendicate come tali, con una temeraria faccia di culo.
[Per citare solo due dei più recenti tentativi di accreditare come
partito «di
sinistra»
quello che ormai sarebbe il caso di ribattezzare PdR (Partito di
Renzi), bastino quelli di Francesco Cundari con «L’ottimismo
è di sinistra (e pure marxista)»
(Left Wing,
17.1.2017) e «Una
Leopolda gramsciana»
(l’Unità,
14.3.2017), che è difficile dire se più irritanti o esilaranti.]
Il fatto che Matteo Renzi
vinca le primarie del Pd con il 68% nel 2013 e con il 71% nel 2017,
dunque, non è da interpretare come investimento sull’uomo
che promette di dare al partito una salda e duratura egemonia
culturale e politica, costi quel che costi, fosse pure il rendere
sempre più problematico poterlo dire (anche solo in parte, e per
«pura
figura retorica»)
«di
sinistra».
Al contrario, rivela in una consistente parte di quell’elettorato
che cominciò a votare il Pci dal 1975 in poi, per rimanervi fedele
mentre diventava Pds, e poi Ds, fino a confluire nel Pd,
un acquistato disinteresse per quella «pura
figura retorica»
del socialismo che prima sembrava indispensabile a far da velo a un
partito borghese, dunque sostanzialmente prono alla logica del
capitale.
Un punto, tuttavia, resta da
chiarire sul perché, e sul come, sia venuta a mancare la
preoccupazione di salvare almeno le apparenze, fino a sentire
rivendicare quasi con orgoglio una sostanziale neutralità ideologica
nell’analisi
dei problemi e nella ricerca delle soluzioni.
[È il caso, per esempio, delle politiche riguardanti il flusso di
migranti dalle coste africane verso quelle italiane: dopo aver
affermato che
«il
problema della sicurezza non è di destra, né di sinistra»,
si è passati a rivendicare come senza dubbio «di
sinistra»
la soluzione dei Cpr avanzata da Marco Minniti in forza della sola
ragione che sarebbero più efficienti dei Cie, così come definiti
nel 2008 dal governo allora presieduto da Silvio Berlusconi, e con
Roberto Maroni agli Interni: stessa logica concentrazionaria, ma –
appunto – più efficace, e senza alcuna rottura rispetto al modo in
cui il centrodestra concepiva e affrontava il problema.]
Senza addentrarci troppo
nelle dinamiche socio-economiche che hanno cambiato corpo e faccia al
ceto medio negli ultimi trent’anni
(con una
sensibile accelerazione
negli ultimi venti, diventata convulsa negli ultimi dieci), potremmo
semplificare dicendo che la crisi in cui è precipitato sul piano
economico, prima, e su quello culturale, dopo, ha sottratto il lusso
di poter essere «di
sinistra»
a buona parte di quell’elettorato
che dal 1975 in poi ha preso a votare Pci-Pds-Ds-Pd, finendo infine
per toglierle anche il lusso di onorarne almeno la «pura
figura retorica».
In buona sostanza, parliamo
di quella «aristocrazia
operaia»
che non è affatto da intendere come la parte degli operai meglio
pagati, ma come quell’eterogeneo
insieme di dirigenti e di funzionari
di partito e di sindacato, di intellettuali (giornalisti, scrittori,
ecc.) in maniera diretta o indiretta orbitanti attorno al Pci, prima,
e al Pd, poi, e dei parlamentari, dei consiglieri regionali,
provinciali e comunali in rappresentanza nazionale o locale del
partito (cui ovviamente vanno aggiunti i componenti dei loro staff e
quant’altri
adibiti in pianta stabile alle attività di propaganda sovvenzionate
dal partito).
Per
il progetto di «egemonia
culturale»
perseguito dal Pci fin dai primi anni dell’ultimo
dopoguerra, quando gli accordi di Yalta sbarrarono la strada ad ogni
soluzione violenta per la presa del potere in Italia, questa
«aristocrazia
operaia»
è venuta a rappresentare una consistente porzione della base
elettorale comunista, ampliandosi nei numeri proprio grazie alle
politiche sociali promosse dal Pci nel regime di sostanziale
consociativismo pattuito con la Dc.
Scrive
Venè nel lavoro già citato: «La
borghesia comunista è composta da borghesi che, con il loro voto,
hannofatto del Pci un partito candidato ad entrare nell’area
del potere. Quali interessi e quali prospettive può avere un
borghese per offrire il proprio suffragio a una forza politica che,
per propria natura, dovrebbe essere “antiborghese” e
“anticapitalista”? […] Tutto ciò pone il Pci di fronte a una
serie di scelte essenziali, delle quali si cerca di non parlare mai,
e meno che mai nell’imminenza
delle elezioni. Quale atteggiamento può assumere, concretamente, un
partito che nasce dal movimento operaio nei confronti dei milioni di
borghesi che si sono giovati delle lotte sindacali per mantenere i
propri privilegi parassitari partecipando allo sfruttamento della
classe operaia? In base a quali criteri il Pci può selezionare,
all’interno
degli strati borghesi, i voti realmente utili alla formazione di una
nuova società da quelli suggeriti dall’opportunismo
o da una semplice fiducia nelle riforme “tecniche” proposte dagli
efficienti quadri di partito? E soprattutto: a quali voti “borghesi”
il Pci dovrebbe rinunciare per tener fede ai suoi programmi di
rinnovamento?».
È
da correggere, dunque, l’idea
che in questi ultimi anni si è fatta strada anche nelle analisi dei
commentatori politici più acuti: con il PdR non siamo dinanzi alla
«mutazione
genetica»
che un post-democristiano avrebbe indotto in un partito che al
momento della fondazione era almeno per tre quarti post-comunista, ma
alla chiusura di quel lento processo che ha portato con successo la
«borghesia
comunista»
a marginalizzare la base elettorale tradizionalmente «di
sinistra»,
per renderla dapprima solo esornativa, quasi esclusivamente
epidittica nella narrazione del partito «di
(centro)sinistra»,
fino a espellerla di fatto dal partito. Basti pensare che da tempo in
Parlamento non siede un solo operaio sui banchi del Pd, mentre
abbondano figure dell’«aristocrazia
operaia»,
insieme a imprenditori e notabili di questo o quel potentato. Matteo
Renzi non ha democristianizzato il Pd: è la democristianizzazione
del Pci iniziata nel 1975 ad essersi finalmente palesata in modo
inequivoco, per finire col non avere nemmeno più bisogno di essere
dissimulata.
Ecco
perché la parabola di Matteo Renzi riveste un interesse che va ben
oltre lo studio dell’ennesimo
stronzo a forma di serpente, soprattutto adesso che il pieno
controllo del Pd gli consente di non avere altri freni lungo la
discesa. È chiaro che, per assecondare la sua malata smania, non
potrà che stringere un patto col centrodestra un minuto dopo aver
incassato il risultato delle prossime elezioni politiche, e alla
perdita di consensi cui lo porterà la frettolosa rimozione della
lezione del 4 dicembre si aggiungerà quella ulteriore conseguente
alla grande coalizione che stringerà con Silvio Berlusconi, la cui
vita non si prospetta facile, né lunga, a fronte delle spinte che
verranno da un paese ormai avvitato in un declino dal quale potrebbe
venir fuori solo con politiche sgradite tanto all’elettorato
del centrodestra quanto a quello del Pd, per quel che ormai è
diventato. Matteo Renzi non consegnerà l’Italia
al M5S nel 2018, ma nel 2020 o nel 2021 senza meno.
È
solo lì che la sua parabola toccherà il punto più basso, e quasi
certamente gli risulterà assai più doloroso di quanto oggi sia in
grado di immaginare, perché il «buon
selvaggio» di
Rousseau, contrariamente a quanto riteneva Rousseau, sa essere
candidamente cattivo, praticamente una bestia.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)