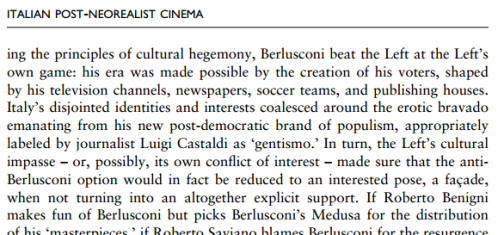Un
«dibattito»
– prendo la definizione che ne dà il De
Mauro –
dovrebbe essere una «discussione
di più persone nella quale le diverse opinioni vengono discusse e
vagliate».
Avvenire
parte male fin dall’occhiello,
dunque, nel presentare come «dibattito»
i tre interventi pubblicati a pag. 3 del numero in edicola martedì 9
maggio, perché questi non esprimono affatto «opinioni
diverse»:
Lucio Romano (Disposizioni
o dichiarazioni: la differenza è di sostanza),
Gian Luigi Gigli (Ridurre
la portata negativa di una legge nata male)
e Carmelo Leotta (Se
un pm afferma che una vita vale meno)
hanno un dichiarato idem
sentire
sulle tematiche relative al «fine
vita»
e a tutti e tre non vanno affatto bene le
Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento
approvate alla Camera lo scorso 20 aprile.
Più che un «dibattito»,
insomma, Avvenire
manda in pagina un monologo a tre voci, e a tanto, già di per sé
irritante, aggiunge il carico, francamente insopportabile, di dar
conto delle possibili «opinioni
diverse» unicamente
attraverso l’infedele
esposizione
che ne fanno i tre prestigiosi avanzi di sagrestia chiamati a intervenire sul
tema.
Un modo molto disonesto di procedere, perché neppure il fatto di
essere un organo di partito – cos’altro
è, la Cei? – solleva Avvenire
dall’obbligo
di dare una corretta informazione ai suoi lettori. Ma veniamo al
merito.
«Le
disposizioni anticipate di trattamento –
scrive Lucio Romano – si
rappresentano come estensione nel tempo di un consenso informato
anticipato [ma]
solo ad una lettura generica […] possono essere assimilate al
consenso informato, [che]
è accettazione libera, cosciente, attuale, revocabile e consapevole
del paziente a sottoporsi ad un atto medico, con una informazione
preliminare, adeguata e specifica, circa benefici, rischi,
complicanze correlate o prevedibili».
Bene, tutto questo verrebbe meno col concedere ad un individuo il
diritto di decidere per tempo sul proprio «fine
vita»,
perché «le
“disposizioni” esprimono volontà vincolanti da seguire quando
non più in grado di esprimersi».
In più, «non
sono assimilabili al consenso informato perché, seppur stabilite in
libertà e consapevolezza, non potranno essere mai attuali perché
redatte “ora per allora”; dovranno essere prevalentemente
generiche non potendo definire lo specifico; non sono informate in
quanto formulate prima dell’insorgere della patologia, senza
conoscenza di circostanze e modalità; non potranno essere più
revocabili in situazione di irrecuperabile incapacità di intendere e
di volere».
La natura capziosa di quest’argomentazione
si rivela al solo controbattere che in questione è quello che
comunemente è detto «biotestamento»,
e cioè un testamento relativo alla vita, inteso come bene personale
del quale è lecito disporre come meglio di creda. Superfluo rammentare che, al pari di ogni testamento, anche quello relativo al «fine vita» può avere revisioni senza limiti.
Accogliendo le
obiezioni di Lucio Romano, non dovrebbe esserci permesso di far
testamento su alcun bene di nostra proprietà. Non dovremmo forse
ritenere valide le disposizioni di quanti hanno lasciato i loro averi
alla Chiesa? Certo, hanno deciso in libertà e consapevolezza, ma il
loro testamento fu redatto “ora
per allora”,
senza poter essere più revocabile in situazione di irrecuperabile
incapacità di intendere e di volere. Dovremmo ritenere nulle, perché
illegittime, quelle disposizioni? Lo Stato dovrebbe procedere alla
confisca di tutti quei beni che nel corso dei secoli tanti privati
cittadini hanno lasciato alla Chiesa?
La fin troppo prevedibile
controbiezione a questa che in realtà – confesso – è una
provocazione (voleva provocare proprio una controbiezione del genere) è la
seguente: la vita non è un bene di cui si possa liberamente
disporre. Bene, ma allora, prima di contestare la legittimità di
quanto viene concesso al cittadino nelle Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento,
si chieda al Parlamento di approvare una legge che sanzioni il
tentato suicidio, anche quando non sia assistito. Per il suicida che
riesca nel suo intento, infatti, sarà impossibile procedere (ci penserà Dio
a ficcarlo nel girone dei violenti verso se stessi), ma a chi
fallisce spetterebbe una pena, e severa. Vedete a cosa costringe, uno
come Lucio Romano? A prenderlo sul serio, e con quanto ne consegue.
E
già accaduto, perché l’ho
conosciuto personalmente. Era un assistente nel reparto di Ostetricia
e Ginecologia dove io facevo il praticantato di specializzando, e un
giorno mi chiese di procurargli qualche immagine ecografica di
embrione alla sesta o settima settimana di gestazione, ne doveva ricavare delle diapositive per i sermoni pro-life che a quei tempi –
parlo degli anni a cavallo dei Settanta e degli Ottanta del secolo
scorso – teneva per conto di Carlo Casini, l’allora
presidente del Movimento
per la vita.
Quando gliene diedi una mezza dozzina, le guardò deluso: «Non
si poteva far di meglio? Sembrano solo fagiolini». Gli risposi:
«Quello sono, Lucio, tutto il resto spetta all’immaginazione».
Ma divagavo, torniamo alla pagina di Avvenire.
Il
secondo intervento, a firma di Gian Luigi Gigli, che di Carlo Casini
ha preso il posto, mira a reclutare forze per impedire che la legge
approvata alla Camera superi il vaglio del Senato.
«È
giunto il momento –
scrive – di
chiedersi se c’era davvero bisogno di una simile legge». [Invece di «c’era»,
forse, andava meglio «ci
fosse»,
ma possiamo chiudere un occhio, perché Gigli non è un grillino.] La
risposta? «Certamente
no, se l’intenzione era di evitare situazioni di ostinazione
terapeutica. La medicina ha superato ogni tentazione in tal senso e,
se non fosse bastato, le esigenze di controllo della spesa sanitaria
e l’intervento degli ordini dei medici avrebbero potuto dissuadere
qualunque nostalgia di accanimento».
Un brivido di orrore ci corre lungo tutto il rachide: sono le
esigenze di controllo della spesa sanitaria tra i motivi a dissuadere
dall’accanimento?
Ma poi: chi potrebbe averne nostalgia? Insomma: chi è il nostalgico
dell’accanimento
terapeutico che si piega dinanzi a basse ragioni di natura economica
quando è in gioco la vita, peraltro inteso come bene indisponibile a chi ne è titolare? La sensazione è che sarebbe difficile
poter avere una risposta, quindi procediamo.
Inutile, la legge, «se
si voleva garantire la possibilità di rifiutare l’avvio di
trattamenti non desiderati. La redazione del consenso informato è
obbligatoria negli ospedali e un medico non potrebbe imporre
trattamenti senza ricorrere all’intervento dei carabinieri ed
esponendosi a rischi e rivendicazioni».
Certo, ma il concetto di «consenso
informato»
si è storicamente affermato a partire dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
(1948), che la Santa Sede si è sempre rifiutata di riconoscere
proprio per quanto in esse vi è affermato relativamente alla
«libertà
della propria persona»
(art. 3).
Va inoltre rammentato che il Catechismo
della Chiesa Cattolica recita
che, «anche
se la morte è considerata imminente, le cure che d’ordinario
sono dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente
interrotte»
(2279). È questo, infatti, il punto di caduta dell’argomentazione
di Gigli, per il quale «obiettivo
reale [della
legge sul biotestamento] era
evidentemente un altro: permettere l’interruzione di qualunque
trattamento»,
con
riferimento alle «cure
che [il
Catechismo ritiene] d’ordinario
dovute»,
come si esplicita col dire «assurdo»
che una legge definisca «terapie»
l’idratazione e la nutrizione assistite, «per
renderle rifiutabili in qualunque momento».
E qui siamo di nuovo costretti alla provocazione. Sembrerebbe,
infatti, che non si voglia tener conto di cosa esattamente si intenda
per idratazione e nutrizione assistite. Perché queste possano essere
messe in atto, occorre personale medico qualificato, con
l’espletamento
di procedure relativamente complicate, e per mezzo di strumenti che
sono propriamente clinici: come ci si può azzardare a non
considerarle «terapie»?
Parliamo di tubi e siringhe, non di acqua e pane. E perché un malato
non avrebbe il diritto di rifiutare un sondino nasogastrico, se poi
può rifiutare una qualsiasi infusione che anche lo stesso Gigli
sarebbe disposto a concedere costituisca «accanimento
terapeutico»?
Col
terzo intervento mandato in pagina da Avvenire
possiamo cavarcela più brevemente.
Carmelo Leotta se la prende col
pm che ha fatto domanda di archiviazione per Marco Cappato,
autodenunciatosi per aver accompagnato Fabiano Antoniani in Svizzera,
aiutandolo in tal modo ad esaudire la sua volontà di procedere ad un
suicidio assistito, e scrive che «l’articolo
580 parla chiaro e stabilisce che “chiunque determina altrui al
suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne
agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio
avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni”»,
mentre invece nelle motivazioni alla richiesta di archiviazione viene
affermato un «principio
di dignità [che] impone l’attribuzione a tutti coloro che vivono
in condizioni gravissime o irreversibili, percepite dal malato come
lesive del senso della propria dignità, “di un vero e proprio
diritto al suicidio”, esigibile non solo in via indiretta con la
rinunzia alla terapia ma anche in via diretta, con l’assunzione di
una “terapia finalizzata allo scopo suicidario”»,
e questo gli pare scandaloso, perché così si affermerebbe una grave
disparità di diritti, che in apparenza sarebbe in favore del
soggetto ammalato
e a scapito del soggetto sano, ma che in realtà farebbe passare il
principio che «la
vita del malato “vale” meno della vita del sano, visto che il
primo ne può disporre, e il secondo no».
L’eleganza con la quale ci è presentato il sofisma non ci consente
di liquidare anche qui l’argomentazione con una provocazione.
Verrebbe, sì, di tagliar corto obiettando che, tanto per fare un esempio,
anche nel caso della legittima difesa una vita (quella
dell’aggressore) finisce col “valere”
meno di un’altra (quella dell’aggredito), ma che al momento il Codice
Penale
(art. 52) continua a contemplarla come «legittima»,
così consumando quella che per Leotta sarebbe «una
insanabile violazione del principio di uguaglianza». Verrebbe da esortarlo a portare l’art. 52 dinanzi alla Consulta, e subito, perché lì dentro passa un’intollerabile differenza di “valore”
che
ci sarebbe tra vita e vita. Verrebbe, ma rinunciamo.
Lasciamo che dinanzi alla Consulta vengano portati gli artt.
579 (Omicidio
del consenziente)
e 580 (Istigazione
o aiuto al suicidio),
ma poi non mettiamo cruccio al musetto se saranno dichiarati
incostituzionali sulla base delle stesse motivazioni che il pm ha
addotto in favore dell’archiviazione. Se ci si appella alla legge
degli uomini, non sempre si ha risposta illuminata dalla legge di Dio. E siamo sicuri che Leotta non abbia bisogno di esempi.