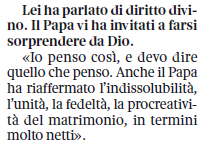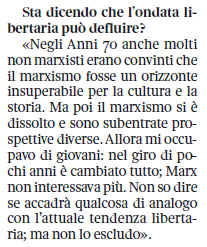Nel
loro Traité de l’argumentation
(1958), che su queste pagine torna di tanto in tanto come strumento di decriptaggio del messaggio che scorre subdolo, Perelman e Olbrechts-Tyteca ci avvertono che, «quando in una discussione non formale la
tautologia appare evidente e voluta, come nelle espressioni del tipo “un soldo è
un soldo”, “i bambini sono bambini”, essa dovrà essere considerata una figura»:
in pratica, «si utilizza un’identità
formale fra due termini che, se l’enunciato deve presentare qualche interesse, non
possono essere identici», e dunque «l’interpretazione
della figura, che vorremmo chiamare “tautologia apparente”, esige un minimo di
buona volontà da parte di chi legge». Anche meno del minimo basta per dare il giusto senso al delizioso editoriale di Giuliano Ferrara su Il Foglio di lunedì 27 ottobre –
quando è giusto complimentarsi, qui non ci si sottrae – che ha l’unico
difetto di avere un titolo assai loffio (Cari berlusconiani
spaesati, spremetevi per una volta le meningi), mentre sarebbe stato perfetto con Un servo è un servo.
Tautologia apparente, perché i due termini non sono identici. Il secondo servo, infatti, è da intendere in modo letterale, ancorché nell’accezione estensiva, che non dà alcuna informazione su causa e natura della sottomissione, ma si limita a definirne il modo. Il primo, invece, è l’ellissi dell’individuo che si esaurisce nella sua pulsione gregaria: «dipendete storicamente da
lui e solo da lui, sarete anche personalmente rispettabili individui dotati di
autonomia, e certo che molti di voi lo sono, ma come gruppo politico avete
investito tutto quel che avevate sulla leadership personale del Cav., e per
anni, lunghi anni, avete rinunciato a ogni autonomia politica e di pensiero, a
ogni autentico contrasto, avete votato tutto, contribuito a un mezzo culto della
personalità, e non sempre con buon gusto la vostra personalità collettiva è stata
sacrificata all’idolo che vinceva, era opulento, distribuiva riconoscimenti e
onorificenze perfino oltre i meriti, in molti casi». Siete questo e «ora fate obiezione
politica e di coscienza sulla linea, addirittura»? Ma come vi permettete? Un servo è un servo.
Giusto complimentarsi, perché l’editoriale è un bel redde rationem, degno d’un Étienne
de La Boétie. (Oddio, forse qui esagero, non so se Étienne de La Boétie sarebbe arrivato a scrivere: «Ricordatevi
la nipote di Mubarak, su, non fate i sepolcri imbiancati», ma, insomma, semel transeat.) E tuttavia una precisazione è necessaria, e anche qui torna utile il Traité de l’argumentation, per ciò che attiene alla distinzione tra il dire e il dit, dove quella che August Baron chiama sillepsi oratoria (De la rhétorique, 1849) si annulla nella coincidenza tra senso proprio e senso figurato: per farla facile, direi che il redde rationem non è rivolto a chi ha la colpa di essersi fatto servo, ma a chi non ha diritto di essere altro, e non già per propri limiti, ma per la ratio intrinseca alla cosa umana. Neanche è tutto, perché c’è pure la condanna ad una ineludibile coazione a ripetere: «Avete
un candidato credibile che sia suscettibile di affascinare e trascinare gli
italiani in una nuova fase dell’azione pubblica?». Potete liberarvi del padrone solo scegliendovene un altro. Il dit suona moraleggiante, il dire è quello del maggiordomo che riprende la servetta sorpresa a spruzzarsi l’eau de cologne della signora.