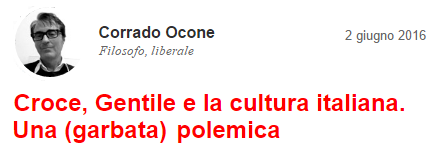Era
evidente che Berlusconi mentisse innanzitutto a se stesso. Cercava di
fotterti, questo è indubbio,
ma sembrava
che gli fosse possibile solo dopo essersi convinto che in fondo eri
tu a voler essere fottuto, irresistibilmente
attratto a entrare nella stessa bolla, gonfiata di bugia in bugia,
che proteggeva lui, e avrebbe voluto proteggere anche te, dalla realtà.
Insomma, che vendesse zerbini in acrilico spacciandoli per tappeti
persiani è fuori discussione, ma dava l’impressione
che per farlo avesse bisogno di credere che, oltre che per lui che li
vendeva, fosse un affarone anche per chi ne avesse comprato uno.
Direi che in ultima analisi appartenesse a quella categoria di
bugiardi ai quali «placere
libet de suaviloquio, qui tamen veris mallent placere, sed quando non
facile inveniunt vera quae grata sint audientibus, mentiri eligunt
potius quam tacere»
(Agostino d’Ippona
– De
mendacio,
11, 18).
Vorrei non mi si fraintendesse: al pari di ogni impostore,
meritava di essere spalmato di pece e cosparso di piume, per poi
dargli fuoco. Sia chiaro, inoltre, che, se quanto finora ho scritto
potrà aver dato l’impressione
di un «coccodrillo»
tirato fuori dal cassetto con qualche anticipo, è solo perché la
stagione delle bugie di Berlusconi è ormai alle nostre spalle. In
realtà, se qualche nota di indulgenza mi sarà scappata, è solo
perché fin dall’inizio
l’intenzione
era di mettere a confronto due campioni di impostura che per tanti si
somigliano, e che invece sono differenti.
Tornando ad Agostino d’Ippona,
infatti, c’è
pure l’impostore che appartiene alla categoria dei «gaudentes
de ipsa fallacia»
(ibidem), quelli amano fotterti per il piacere di fotterti, e che, prima di fotterti, mentre ti stanno fottendo e dopo che ti hanno fottuto, restano sempre fuori dalla bolla nella quale hanno cercato di chiuderti. A differenza di quelli che ti attraggono in una menzogna nella quale sono già in precedenza riparati per proteggersi dalla realtà, questi ti ci spingono dentro, rimanendone fuori. Parlo di
Renzi, si sarà capito, ed è proprio questa differenza
che, a mio modesto avviso, consente di affermare, come ho già fatto,
«era
meglio Berlusconi»,
rigettando l’obiezione
«ma
no, è che il passato ci sembra sempre più innocuo alla luce del
presente»
(formamentis).
Reduce, come sono, da due infortuni causati da un’eccessiva
leggerezza nell’argomentazione
(vedi il post qui sotto), mi auguro che il lettore vorrà scusarmi se
qui probabilmente l’appesantirò
più del necessario per dar ragione di quanto sostengo. Avevo intenzione di farlo analizzando quanto Renzi ha detto nel corso della conferenza stampa tenuta lunedì mattina a commento dei risultati del primo turno delle Amministrative, ma in serata ha licenziato via Facebook una eNews che condensa tutte le bugie dette alcune ore prima e questo mi semplifica le cose.
Come
ai vecchi tempi il giorno dopo le Elezioni hanno vinto tutti. Tutti
sorridono davanti alle telecamere per dire che loro sì che hanno
trionfato, signora mia. Spiacente, io non sono fatto così. E l’ho
detto chiaro: non sono contento, avrei voluto di più. Non sarò mai
un pollo di allevamento della politica che ripete le stesse frasi
banali ogni scrutinio.
Falso.
Tranne il M5S, che peraltro ne aveva piena ragione, visti i risultati
ottenuti rispetto a quelli delle precedenti Amministrative, non si è
sentito nessuno dire di aver trionfato. Non Forza Italia, che per
voce di tutti i suoi maggiori esponenti ha ammesso il crollo,
limitandosi a imputarne ogni causa all’odierno
stato di frammentazione del fronte del centrodestra. Tanto meno
Fratelli d’Italia,
che sul passaggio della Meloni al ballottaggio aveva investito tanto.
Né trionfalistico è suonato il commento di Salvini, che tutt’al
più ha manifestato soddisfazione per la pessima prestazione data dal
Pd. Nessun tono entusiastico neppure dalla sinistra che per lo
slittamento al centro del Pd è d’improvviso
diventata «radicale»,
come se al momento in Italia ne esistesse un’altra
«moderata»:
Fassina non ha fatto mistero della sua delusione, limitandosi a dire
che considerava il risultato ottenuto come la base di partenza per
future più ampie aggregazioni. Falsa, dunque, la premessa, che
d’altronde,
come sarà subito evidente dall’analisi
di quanto segue, sembra servire solo a ribadire quel ruolo di rottura
rispetto ai «vecchi
tempi». Ancora più evidente, il dato, in conferenza stampa, dove ha
fatto esplicito riferimento al «teatrino politico della Prima
Repubblica». Come vedremo subito, invece, siamo alla lettura dei
risultati elettorali che era tipica della Dc all’indomani
di una flessione della percentuale dei consensi. «Noi del Pd,
abituati a vincerne tante, per non dire “abituati a vincerle quasi
tutte”...».
Intendiamoci.
Il PD rimane saldamente in testa, i suoi candidati stanno intorno al
fatidico 40% in molte città, siamo l’unico
partito nazionale.
«Molte
città», si badi bene, non «molti comuni». Di fatto, la somma dei
voti che vanno al Pd nei comuni in cui «i suoi candidati stanno
attorno al fatidico 40%» non arriva neanche a un decimo a quelli
raccolti dai candidati che ha presentato a Roma e a Napoli, dove
stanno a poco meno o poco più della metà, arrivando solo per un
pelo al ballottaggio, nel primo caso, e neppure a quello, nel
secondo. Tranne che a Rimini, Caserta, Cagliari e Milano, dove
guadagna pochissimo, il Pd perde voti ovunque rispetto alle
precedenti Comunali, con un calo percentuale medio del 5-6%, fino un
massimo del 18% (Carbonia), mentre il calo di voti medio si attesta
intorno al 23%, con una punta massima del 56% (Latina). È una
batosta che andrebbe ammessa, signora mia, ma l’impostore
vanta una tenuta che non c’è
stata, limitandosi a dire che si aspettava di più, quasi che avesse
vinto, ma, aspettandosi di stravincere, non possa dirsi pienamente
contento. Però si consola coi risultati degli avversari...
Cinque
Stelle che canta vittoria governa in appena 17 comuni (compresi
espulsi, sospesi e disconosciuti) su ottomila, cui vanno aggiunti
altre quattro municipalità ieri. Il movimento di Grillo e Casaleggio
è andato al ballottaggio in venti comuni sui 1.300 in cui si votava.
Cinque
Stelle si presentava solo in pochi comuni. Molti di più di quelli in
cui si presentava alle precedenti Comunali, segno di ma lenta ma
progressiva presa sul territorio, che mira a coprire tutta l’Italia.
Lasciando da parte ogni giudizio di merito, per un movimento politico
che fino a pochi anni fa non aveva neanche il suo simbolo sulle
schede elettorali, è uno strepitoso successo che può essere
ridimensionato solo trascurando la crescita che gli è alle spalle.
Discorso uguale e contrario a quello del Pd: si può negare il suo
declino solo trascurando che Dc e Pci arrivavano insieme a oltre il
70% dei voti, che Veltroni è arrivato a prenderne un massimo di
dodici milioni e dispari, mentre già il Renzi delle Europee toccava
a malapena di undici. Discorso che ovviamente non tiene conto dei
contesti e delle variabili, ma in sostanza è proprio questo che fa
Renzi nel dare un quadro gramo dell’odierna
situazione dei Cinque Stelle. Risibile, poi, il richiamo a «espulsi,
sospesi e disconosciuti»,
con un Pd che tra amministratori indagati e sotto processo batte il
record che era del Psi ai tempi di Mani pulite.
La
Lega crolla, Salvini sta sotto il 3% a Roma ed è doppiato da
Berlusconi a Milano, doppiato! Forza Italia esiste ancora e ottiene
risultati positivi a Napoli, Milano, Trieste. Ma scompare da Cagliari
a Torino, da Bologna a Roma.
Sta
di fatto che proprio i pessimi risultati ottenuti dalle forze che
prima erano del Pdl sono un importante stimolo alla riaggregazione in
un cartello che gli istituti demoscopici danno poco al di sotto o
addirittura poco al di sopra del Pd. L’Italia
non è mai stato un paese di sinistra, e forse non lo sarà mai.
D’altronde
è proprio la frenetica corsa al centro che il Pd ha iniziato con
Renzi a dar ragione di un elettorato di nuovo pronto, dove se ne
presenti l’occasione,
a mandare a Palazzo Chigi un leader del centrodestra che non sia
mezzo morto come Berlusconi, non sia troppo inquietante come Salvini
e non sia poco convincente come Meloni. Trovarlo non sarà facile,
certo, ma ripetute prove di fallimento a marciare disuniti possono
essere il miglior pungolo a ritrovare un’intesa.
Soprattutto se Parisi, dato per sicuro perdente appena uno o due mesi
fa, dovesse battere Sala. Cosa non impossibile, a quanto pare.
La
sinistra radicale che per mesi ci ha spiegato come funzionava il
mondo non entra in partita né a Roma, né a Torino dove aveva
scommesso tanto.
Ma
è pronta a votare Raggi contro Giachetti e Appendino contro Fassino,
anche se non può ammetterlo esplicitamente. È probabile che in
parte finirà perfino per votare Parisi contro Sala, pur di insegnare
a Renzi che sa come funziona il mondo e nei casi estremi vi si
adegua.
Ma
una volta che abbiamo fatto questa lunga analisi del voto...
Lunga?
Sbrigata in poche battute, quasi per eluderla.
Una
volta che abbiamo fatto questa lunga analisi del voto, per me cambia
poco perché non è che “mal comune mezzo gaudio”: continuo a non
essere contento.
E
ci sarebbe mancato solo questo. Bastava contare quante volte ha
deglutito in conferenza stampa. Dopo venti minuti scarsi, già
premeva perché si levassero baracca e burattini. A quella che seguì
le Europee era fresco e tosto fino all’ultimo
minuto, e soprattutto si presentò da solo: qui ha avuto bisogno
della compagnia dei due vicesegretari, del presidente e della
responsabile degli enti locali. Quando vince, ha vinto lui. Quando
perde, ha perso il partito.
A
Napoli città il PD praticamente non c’è
dal 2011: finita la fase del ballottaggio proporrò alla direzione un
commissariamento coraggioso.
E
così si liquida la trombatura di una candidata che hai scelto tu?
Così si liquida la sconfitta in una città dove hai speso il massimo
per ottenere il risultato, da segretario del partito e – vergogna –
da presidente del consiglio? La città laboratorio che doveva testare
l’alleanza
con Verdini. Che c’è
da commissariare che non lo fosse già da prima?
A
Roma Giachetti ha fatto mezzo miracolo a riportarci al ballottaggio:
non escludo che riesca a fare anche l’altro
mezzo, ma deve recuperare dieci punti di svantaggio. Olimpiadi,
sicurezza, capacità di guidare una macchina complessa come il Comune
di Roma: se la giocheranno su questo. Temi amministrativi, insomma,
non di politica nazionale.
Insomma,
se Giachetti perde, sia chiaro che ha perso solo Giachetti.
Che
non sia un dato nazionale, del resto, si vede chiaramente dalla
geografia: zone anche limitrofe vedono risultati molto diversi. È
ovvio. Gli italiani sanno votare, sono liberi, scelgono di volta in
volta. Fanno zapping in cabina elettorale perché non è più tempo
di indicazioni dall’alto
dei partiti.
Per
questo il signorino si appresta a far votare ancora una volta la
fiducia su una legge elettorale che fa del Parlamento un accrocchio
di cooptati. Buona, la metafora dello zapping, ma per uno spettacolo
a reti unificate, tale da allontanare lo spettatore dalla tv.
E
quindi può accadere di tutto, come in realtà è accaduto a questo
primo giro. Dunque: onore ai sindaci eletti al primo turno, in bocca
al lupo a chi corre per il secondo giro e un caloroso abbraccio a chi
continua a urlare “Ho vinto!” anche quando la realtà dice
un’altra
cosa. Ma proprio perché non sono come gli altri a me la scenetta di
dire che “abbiamo non perso” non è mai riuscita e non riuscirà
mai. Possiamo e vogliamo fare meglio, lo faremo. Punto.
Come
si è visto, non siamo di fronte all’impostore
che ci invita a condividere la menzogna nella quale si è rinserrato
per proteggersi da una realtà sgradevole: si tratta di un mascalzone
patentato, che mente sapendo di mentire, e non si fa scrupolo di
renderlo manifesto. Anche Berlusconi era così? Può darsi, ma una
differenza c’era,
e non era irrilevante: quando i fatti si incaricavano di spalmarlo di
pece, coprirlo di piume e dargli fuoco, strepitava come un ossesso;
Renzi si atteggia a étoile ne L’Oiseau
de feu.