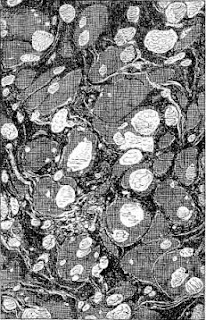L’Osservatore Romano di martedì 23 marzo offre al lettore il testo della relazione con la quale Agostino Paravicini Bagliani ha aperto giorni fa, a Sulmona, un convegno su Celestino V: “colui che fece per viltade il gran rifiuto” rinunciando all’immenso potere che a quei tempi era in mano a un pontefice romano – cosa curiosa – non vi è mai nominato, mentre invece vi ricorre ben nove volte – se non me n’è sfuggita una decima – il nome di Innocenzo III, un papa che più diverso da Celestino V proprio non si può: un papa che fu l’incarnazione stessa della teocrazia cristiana, e che diede al potere del pontefice romano una forza così intensa che di poi sarebbe potuta solo scemare.
Cosa curiosa, ma forse neanche troppo, perché per capire la portata del rifiuto di Celestino V non è affatto secondario capire quanto esteso e intenso fosse, a quei tempi, il potere del papato in Italia e in Europa; e i cenni a Innocenzo III che sono nel testo di questa relazione ne danno un brillante ritratto, impressionistico e impressionante.
Innocenzo III si conferisce “plenitudo potestatis” (i laici sotto, il clero sopra e, al vertice del clero, il papa, guida politica e spirituale); si dà il titolo di “caput et fundamentum totius christianitatis” (“necessità e utilità di tutto il popolo cristiano”); si dichiara Dio in terra (gli ultimi erano stati gli imperatori romani); batte moneta, riscuote tasse, si costruisce un palazzo apostolico con caratteristiche di fortezza imperiale; si celebra in prove di egemonia culturale mettendo il tallone sul pensiero, le arti e le scienze, e asservendo tutto all’obbedienza. Un criminale, insomma, così verrebbe spontaneo dire se uno volesse cedere all’antistoricismo.
Il Bagliani non andava fuori tema, forse. Nemmeno io, però. E infatti mi sono intrattenuto su Innocenzo III partito per dare una risposta a Ernesto Galli della Loggia che, sul Corriere della Sera di domenica 21 marzo, lamentava da parte delle “società occidentali un atteggiamento sprezzante, quando non apertamente ostile, verso il cristianesimo”. Lamentava una “contestazione sul terreno dei principi”, un “radicalismo enfatico nutrito d’acrimonia” verso le stesse radici cristiane d’Italia e d’Europa. Lamentava che alla Chiesa di Roma ci si rivolga sempre più spesso con un “tono oltraggiato e perentorio che dà tutta l’idea di voler preludere a una storica resa dei conti”, con “la ridicola condanna di tutte le malefatte, le uccisioni e le incomprensioni addebitabili al cristianesimo”, e con l’antistoricistica “applicazione dei criteri di oggi ai fatti di ieri”. Lamentava che “lo stesso senso comune della maggioranza stia diventando di fatto anticristiano”, a causa di un ignorante e volgare “illuminismo divenuto chiacchiera da bar”. Lamentava “quel feroce tratto nazionale che per principio non può credere in alcuna cosa che cerchi la luce, che miri oltre e tenga lo sguardo rivolto in alto, perché ha sempre bisogno di abbassare tutto alla sua bassezza”…
Col massimo rispetto per tutta questa afflizione: questo accade in reazione alle pretese del papato. Che non è più quello di Innocenzo III, certo. Ma che non lo è più, non già perché il papato abbia ceduto o distribuito potere, ma perché gliene è stato sottratto, non senza resistenze.
Le pretese odierne del papato hanno cambiato solo la forma: il papa continua a conferirsi “plenitudo potestatis” (diretta sul piano spirituale e indiretta su quello politico); non batte più moneta e non riscuote più tasse, perché la storia gli ha scippato queste prerogative, lasciandogli una rendita parassitaria, cioè da parassita, e però la sua corte è fortezza. Non è più Innocenzo III, ma per lui il Medioevo rimane il top.
Professore, chi è antistoricista? Chi è stato costretto a rinunciare alle pretese del IV Concilio Lateranense, e continua di fatto a ritenerle legittime o, invece, chi ravvede nella natura stessa del papato, sempre diversa e sempre uguale, il vero oltraggio alla storia?
Cosa offende di più la storia, professore, l’“applicazione dei criteri di oggi ai fatti di ieri” o viceversa?