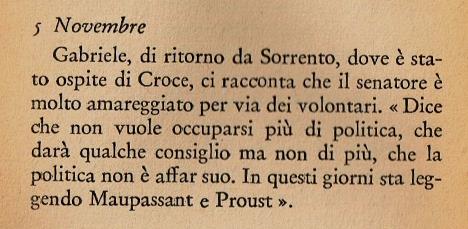mercoledì 31 luglio 2013
venerdì 26 luglio 2013
«Mi pare che in Beethoven manchi il ritmo»
Albert Willem
de Groot ha segnalato una cinquantina di significati diversi del termine «ritmo»
(Der Rhythmus) ed Edgar Willems è arrivato a contarne ben quattrocento (Le
rythme musical). E dunque a cosa fa riferimento, Giovanni Allevi, quando
afferma: «Mi pare che in Beethoven manchi il ritmo»? Parla della strutturazione,
dello sviluppo o della periodicità? Fa forse riferimento al «metro», che però è solo
uno degli elementi dell’organizzazione della durata? «Il ritmo non è un
concetto univoco, ma un termine generico – scrive Paul Fraisse (Le structures
rythmiques) – sicché solo l’analisi del testo musicale può individuarne le
componenti dando ad esse unità gerarchica», e Allevi non cita una composizione in
particolare, dice «in Beethoven», come se la mancanza di «ritmo» sia una
caratteristica di tutta la sua produzione: forse vuol dire che in lui non
riesce ad individuare equivalenza di durata tra le parti che confluiscono nella
linea melodica? Può darsi, perché aggiunge che «il ritmo è elemento che manca [anche]
nella tradizione classica [complessivamente presa in considerazione(?)]» e che ha
pienamente afferrato cosa sia, il «ritmo», solo dopo aver lavorato con
Jovanotti. L’avesse detto Guia Soncini, la questione non si porrebbe, ma Allevi
ha studiato in conservatorio e dovrebbe sapere che quel dum-dum che amplifica
il tic-tac del metronomo è peculiarità di certa musica – volendola considerare
tale – ma che ce n’è altra che il battito, il respiro, l’onda di vita che l’attraversa
e la muove, l’ha dentro, e da lì dentro le dà forma e andamento, anche facendo
a meno di una linea di bass & drum. E allora che cazzo significa –
esattamente – «mi pare che in Beethoven manchi il ritmo»? Domande
che nessuno gli ha rivolto. D’altronde la sua uscita fa il paio con le reazioni
che ha suscitato in chi di Beethoven conosce tutt’al più le prime cinque battute
della V Sinfonia, l’An die Freude della IX nell’arrangiamento di Wendy Carlos
per Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971) e forse – dico forse – l’attacco
di Für Elise e qualche passaggio della Mondscheinsonate. Il tutto s’incastona
a meraviglia in un’Italia in cui solo l’analfabetismo musicale è più diffuso
della propensione a polemizzare senza argomentare: solo in Italia un
compositore come Giovanni Allevi poteva essere dapprima salutato come un genio,
e poi trattato peggio di un cane rognoso, per essere eventualmente
riconsiderato un genio dopo la morte, se mai morisse presto, meglio se per leucemia o per overdose; e solo in Italia l’ignoranza riesce a farsi così bene scudo dei
luoghi comuni, dichiarandoli territori sacri, intangibili e dunque
impenetrabili, perciò da rispettare, ma tenendosene alla larga. Avesse detto
che in Hummel manchi il ritmo, affermazione assai più temeraria di quella
analoga che Allevi ha fatto per Beethoven, chi lo avrebbe contestato? Ma Beethoven
è Beethoven: per la plebe cui da almeno vent’anni la scuola d’obbligo non dà
più alcun rudimento di educazione musicale, Beethoven è intoccabile. Nessuno
che abbia chiesto ad Allevi di spiegare cosa intendesse per ritmo, visto che si
tratta di uno dei concetti più controversi e dibattuti nella storia della
musica: tutti a saltargli addosso come furie, come se di Beethoven fossero
consumatori a colazione, a pranzo e a cena. Peggio, come se fossero sentinelle
di guardia al suo mausoleo. Il punto più basso, poi, si è toccato col video che il
maestro Giuseppe Maiorca ha dedicato, in mutandoni da combattimento, «a tutti
quei cretini che pensano che Beethoven non abbia ritmo»: un’esecuzione del
quarto movimento della Sonata n. 18 che per svergognare Allevi sembrava suonata
da Jovanotti. Roba che avrebbe fatto esclamare a Richter:
«Basta! Questo Beethoven ha troppo ritmo!».
giovedì 25 luglio 2013
Perdenti, dunque vincitori
Vent’anni
fa veniva dato alle stampe The Culture of Complaint, che l’anno dopo arrivava
in Italia, per i tipi di Adelphi, con un titolo che già dava un’idea del tipo
di fortuna che cercava qui da noi, e che in sostanza prefigurava la differenza
di stile tra la polemica mossa al «politicamente corretto» di qua e di là dall’Atlantico.
Non che «piagnisteo» tradisse il senso di «compliant», infatti, ma dava una
connotazione caricaturale a «lamentela», cercando – per trovarla con facilità –
una legittimità alla «scorrettezza» come arma polemica.
I risultati sono nei
fatti: mentre negli Stati Uniti la critica al «politicamente corretto» ha
prodotto una riflessione seria anche laddove si limitasse a usare i mezzi della satira di
costume, qui da noi è diventato un esercizio coatto, spesso becero, anche
quando ad applicarvisi erano nomi d’un qualche peso. In tal senso potremmo dire
che con la morte di Giorgio Gaber, che d’altronde aveva anticipato di almeno
due o tre lustri le riflessioni di Robert Hughes, peraltro con intuizioni che
restano folgoranti anche a così lunga distanza, l’Italia ha perso il solo
critico del «politicamente corretto» che abbia mai avuto, per lasciare il campo
a incursioni squalliducce, velleitariamente
provocatorie, quasi sempre volgari, che si sono pressoché esaurite nel dare del
«frocio» a un omosessuale, nel mugugnare per l’odore di kebab nei nostri centri
storici e nel dichiararsi felicemente incompetenti dinanzi all’arte
contemporanea.
Se la critica al «politicamente corretto», insomma, era una
buona occasione per il pensiero conservatore, in Italia è stata sprecata
riducendola ad una forma intrattenimento che tradiva perfino il movente
liberatorio per insterilirsi in tic nevrotico. Questo, quando si trattava de Il
Foglio, per buttare un occhio alla stampa, perché con il Giornale o con Libero, si riusciva a scendere anche più
in basso. D’altra parte accade sempre così con quello che arriva dall’altra
sponda dell’oceano: si copia, ma male. E basta rileggere La cultura del
piagnisteo vent’anni dopo per fare una scoperta che tutto sommato è sconvolgente:
se «la nuova sensibilità decreta che i nostri eroi saranno solo le vittime»
(pag. 23), il ruolo spetta di diritto agli eroicomici disadattati alla
modernità, che dopo aver tentato invano la via del politically uncorrect come
momento di resistenza e di ribellione, possono dichiararsi perdenti, dunque
vincitori.
venerdì 19 luglio 2013
Consigli a Pippo
«Ti vergogni se ti chiamo Pippo?»
Massimo Troisi
Per
avere un’idea plastica del degrado in cui versa la politica in Italia basta
pensare al fatto che il meno peggio sulla piazza è quello schifo del Pd nel
quale quello che fa meno schifo è Pippo Civati. Dico: Pippo Civati. Ecco,
dunque, che a voler chiacchierare di politica senza essere aggrediti dalla
nausea mi tocca parlare di lui.
A pelle mi è simpatico, Pippo, molto simpatico. Anzi, direi di più, ha quasi un che di familiare, sarà che mi rammenta quel fessacchione di Mimmo Miragliuolo al quale in prima media avevamo fatto credere che normalmente il cazzo avesse l’unghia, godendo come pazzi a vederlo seriamente preoccupato che il suo non l’avesse, ma a millantarne una bella grossa, quasi un artiglio. Bene, oggi su Sette c’era un’intervista a Pippo, e su quella mi intratterrò. Non per fargli le pulci, però, piuttosto per dargli dei consigli. Come a prenderlo in disparte per dirgli: «Stai tranquillo, Mimmo, si scherzava: normalmente il cazzo non ha l’unghia».
A pelle mi è simpatico, Pippo, molto simpatico. Anzi, direi di più, ha quasi un che di familiare, sarà che mi rammenta quel fessacchione di Mimmo Miragliuolo al quale in prima media avevamo fatto credere che normalmente il cazzo avesse l’unghia, godendo come pazzi a vederlo seriamente preoccupato che il suo non l’avesse, ma a millantarne una bella grossa, quasi un artiglio. Bene, oggi su Sette c’era un’intervista a Pippo, e su quella mi intratterrò. Non per fargli le pulci, però, piuttosto per dargli dei consigli. Come a prenderlo in disparte per dirgli: «Stai tranquillo, Mimmo, si scherzava: normalmente il cazzo non ha l’unghia».
In primis, dire sì a Vittorio Zincone: grosso
errore, Pippo, Zincone è cattivo come un ragazzino delle medie. E infatti, non
so se te ne sei accorto, l’intervista aveva il chiaro scopo di ridurti a
macchietta. C’è riuscito solo a metà, perché tu hai tirato fuori l’artiglio, ma
«i suoi miti giovanili?», «il film preferito?», «il libro?», «la canzone?» - non
ti sei accorto che ti trattava da adolescente al quale si chiede: «Mi fai
sfogliare la tua Smemoranda?». Mai più, Pippo, sennò ti veltronizzeranno per l’eternità.
In secondo luogo, la foto che corredava l’intervista. Cazzarola, Pippo, non sei
di primo pelo, dovresti sapere che, quando il fotografo si china per scattare
una foto dal basso verso l’alto, sorridere e incrociare le braccia fa salumiere
sulla soglia del negozio.
Il sorriso, poi. Non che un politico non debba
sorridere, per carità di Dio, ma c’è sorriso e sorriso. Hai labbro inferiore
carnoso e commissure labiali accentuate: stira di più quel cazzo di
orbicolare, quando sorridi, altrimenti sembri Winni the Pooh.
La frangetta, poi, vogliamo finalmente parlare di quella
stracazzo di frangetta? A parte il fatto che ti si confonde con la
Serracchiani, ma hai l’arcata sovraorbitaria molto accentuata e le sopracciglia chiare, non ti accorgi che il
tutto ti dà facies da microcefalo? Via la frangetta, Pippo, fronte libera,
taglio severo e basetta alta.
Per finire: le camicie a righini sono d’un triste…
giovedì 18 luglio 2013
Varie
Non so
se sia ancora in catalogo, ad ogni buon modo ve lo consiglio perché si tratta
di un libro eccezionale. Parlo de Il cono d’ombra di Franco Bandini (SugarCo,
1990), una minuziosa disamina dell’intricatissimo groviglio dei servizi segreti
italiani, sovietici, tedeschi, inglesi e francesi nel quale venne a incastrarsi
l’assassinio dei fratelli Rosselli, nel 1937. Per chi ha letto Vita di Carlo
Rosselli di Aldo Garosci (Vallecchi, 1973) sarà un duro colpo sollevare il velo
della leggenda e Il conformista di Moravia sembrerà d’un tratto un manualetto
di disinformazione sul fascismo.
Un’altra
lettura che consiglio è quella di un libricino che raccoglie i contributi di
Donatella Di Cesare, Fabio Milazzo, Laura Cervellione, Corrado Ocone, Lorenzo
Magnani e Simone Regazzoni sul Manifesto del nuovo realismo di Maurizio
Ferraris: Il nuovo realismo è un populismo (il melangolo, 2013). Una
stroncatura senza possibilità di appello. Bene, fanculo a Ferraris.
La
rivolta del vescovo Lefebvre di Ugo Ronfani (Pan Ed., 1977) contiene in
versione pressoché integrale il discorso che l’«antipapa di Ecône» tenne l’anno
prima nel Palazzo dello Sport di Lilla e che segnò la rottura con Roma. È un
riandare alla fonte primigenia di una querelle che si è trascinata per decenni
e che ora pare segnare una rottura definitiva tra la Santa Sede e la Comunità
Sacerdotale S. Pio X. Ho più volte scritto su queste pagine che le basi del
dissenso fossero insanabili e che il tentativo di ricomposizione dello scisma voluto
da Joseph Ratzinger fosse disperato: il discorso di Lefebvre, che fin qui
conoscevo solo in stralci, avrebbe dovuto scoraggiare chiunque.
Dopo
aver chiuso un post nel quale ho espresso un’opinione divergente dal comune
sentire, per quanto possa essere sereno riguardo a ciò che ho scritto, torno
spesso ad approfondire. Così è stato per ciò che ho scritto riguardo alla
Liberazione di San Pietro di Raffaello e così sono arrivato alla monografia di
Luigi Serra (Utet, 1941), che, anche se non tocca il punto relativo alla
velatura in calce sulla quale mi sono intrattenuto, conferma l’impressione
irriverente da me confessata: l’arte di Raffaello è innanzitutto artigianato.
Serra non si è esprime proprio in questi termini, ma – come per il Caravaggio
di Bernard Berenson – fa piacere accostarsi a un critico che guarda l’opera
senza farsi accecare dalla fama dell’autore.
Mi
scrive monsignor *** chiedendomi la rimozione di un post del 2007. Senza arroganza, senza neppure un’ombra di minaccia. Sua
Eccellenza si era dichiarato gay ai microfoni di un cronista de La7, per fare
repentina marcia indietro: «Sono stato un grande ingenuo – disse allora – forse
ho peccato di superficialità. Il ragazzo di La7 è veramente entrato nel mio
studio, il personaggio ripreso sono io. Non contesto le riprese e le evidenze,
è tutto vero. Ma io non sono gay, volevo scrivere un libro, una ricerca sul
problema dell’omosessualità tra i preti, dunque mi sono messo su Internet e ho
cercato siti gay, ho contattato quel ragazzo ed è venuto da me. Fatto sta che
la televisione ha carpito la mia buona fede: in sostanza era solo un
esperimento, uno studio sul tema, e io sono caduto, ma spiegherò tutto ai miei
superiori». Non dev’esserci riuscito e ora cerca di cancellare sul web le
tracce di quella vicenda. Mi ha fatto una così struggente tenerezza che l’ho
accontentato.
Come
tutti i bimbi della sua età, anche il mio Michele adora l’effetto che fa una
cosa che cadendo si rompe. Ovviamente gli si fa presente che «non si fa», ma
non ha trovato difficoltà ad escogitare uno stratagemma che a me pare si offra
come un esemplare filogenesi della morale. Aspetta che ti volti, si assicura
che non stai guardando, getta a terra la cosa e, appena ti rigiri per
constatare il danno, si mette le mani in testa e cominciare a camminare avanti
e indietro lamentando: «Oooooh!». Come a dire: che peccato, che disgrazia, che guaio, che
sventura. Lui non c’entra, tutta fatalità.
Ho
sentito Roberto Calderoli al Senato. Di gran lunga più dignitoso di chi ne ha
preso le difese.
Prezioso volumetto, quello di Gennaro Cesaro (Benedetto Croce in pace, in guerra e in amore - Bastogi, 2012). Raccoglie testimonianze coeve e postume, anche prossime al pettegolezzo, che illustrano a meraviglia la personalità del «Padre Pio di Palazzo Filomarino» e dicono del crocianesimo più di quanto ne dica l’opera di Croce.
sabato 13 luglio 2013
La cosuccia («Strumento di democrazia diretta» / 2)
In uno
dei miei ultimi post («Strumento di democrazia diretta» - Malvino, 2.7.2013) ho
illustrato l’opinione decisamente scettica del socialista Arturo Labriola (1873-1959)
sul referendum, strumento di democrazia diretta – sosteneva – che vuol essere
un «correttivo» della democrazia rappresentativa, ma che in pratica si rileva
sempre «inutile» o «impotente». In parte ho fatto miei i suoi argomenti, che mi sono parsi convincenti, e ho
invitato il lettore a esaminare i risultati dei referendum tenutisi in Italia negli ultimi quattro o cinque decenni liberandoli dalla retorica celebrativa: quello sul divorzio e quello sull’aborto,
solitamente citati per rappresentare l’istituto referendario come il più alto
momento di partecipazione del cittadino alla gestione della cosa pubblica, si
limitarono a ratificare due leggi varate dal Parlamento, mentre la volontà
espressa nell’esito di molti altri – due per tutti, quello sull’abolizione del
finanziamento pubblico ai partiti e quello sulla responsabilità civile dei
magistrati – fu tradita senza troppa difficoltà.
Mi è stato fatto notare che l’esempio
italiano non è il migliore per saggiare potenzialità e limiti dell’istituto
referendario, invitandomi a considerare quello svizzero. È obiezione che fu
sollevata anche alla tesi espressa da Arturo Labriola, che la rigettò portando
a esempio i risultati dei 128 referendum tenutisi nel cantone di Zurigo tra il
1874 e il 1893, e concludendo – sennatamente, a mio modesto avviso – che si era
votato su questioni sostanzialmente irrilevanti. E tuttavia il modello svizzero
veniva da lui contestato nell’impianto: «Il corpo elettorale deve deliberare intorno a
questi punti e deve adottare una decisione. Ogni giudizio di insieme sfugge e
deve evitarsi. La mozione presentata si giudica per ciò che appare. Essa è
quella che è. L’elettore, deponendo nell’urna il suo bollettino, afferma
soltanto che intorno a quel punto determinato la sua volontà è questa o quest’altra.
Non esamina i motivi che hanno determinato la proposta, non questiona intorno
al modo pratico come verrà eseguita, non giudica degli uomini chiamati all’ufficio
delicato di applicare e, meglio ancora, di interpretare la legge: dà un avviso
intorno alla “cosa” e nulla più. Questa è ritenuta una manifestazione di radicale
democrazia, eppure è soltanto una pericolosa illusione […] Carezzando la vanità
popolare col pregiudizio che gli uomini in fondo contino nulla in regime
apparentemente democratico, cioè soggetto alla volontà popolare, e che a nulla
riducasi il potere dei governanti dove essi siano semplici ministri e strumenti
di altrui volere, si sollevano effettivamente questi uomini al di sopra del
comune livello e si dà loro una strana supremazia».
Quand’anche sia di solo
impiego «correttivo» della democrazia rappresentativa, per Arturo Labriola, il
referendum ha in sé il pericolo che sta nella democrazia diretta: parcellizzare
la gestione della cosa pubblica in istanze disarticolate da un progetto di
società, che con ciò non è smarrito nelle contraddizioni del plebiscitarismo,
ma trasferito in modo più o meno occulto nelle mani del demagogo di turno. «Vi
furono forse democrazie più dirette e radicali di quella di Atene? Quale
corruzione vi si esercitasse è roba che si apprende nelle prime scuole. E, a
dirla come sta, e in modo che non ci si senta troppo, è stato sempre più facile
corbellare le masse e corromperle in tutte le forme, che acquistarne i corifei.
[…] Trasferire la responsabilità di un fatto dagli uomini alle masse è già un
modo facile di eliminare ogni responsabilità. […] Il concetto della
responsabilità è un concetto esclusivamente personale. Più oblitera questo
carattere e più si oblitera esso stesso».
Non si scandalizzi, il lettore, ma
questa voleva essere solo la premessa a riflettere su una cosuccia tanto piccina
che sotto tutto quanto fin qui detto rischia addirittura di rimanere
schiacciata per la sua irrilevanza: qualche giorno fa Beppe Grillo ha espresso il
suo favore ai referendum di cui si sono fatti promotori i radicali di Marco
Pannella e oggi Silvio Berlusconi ha annunciato il suo appoggio alla raccolta di firme per alcuni dei quesiti. Due cosucce, dunque? No, una sola. Infatti, a sostenere un’iniziativa referendaria
–
chi nel promuoverla, chi nell’appoggiarla in modo generico, chi nella dichiarazione d’impegno attivo (sebbene limitato ad uno solo dei due pacchetti di quesiti, quello sui temi di natura giudiziaria) – troviamo tre leader politici che tra i molti tratti in comune hanno leadership di tipo carismatico, proprietà di fatto del movimento che guidano e gravi disturbi della personalità. Si tratta della triade che Kets De Vries individua nella figura del demagogo (Leaders, fools and impostors, 1993). Ci troviamo, in sostanza, di fronte al paradigma del momento di democrazia diretta che si fa strumento di quella che per Labriola è «una pericolosa illusione».
A scanso di equivoci, però, occorre qualche chiarimento. Quasi tutti i referendum di cui si sono fatti promotori i radicali pongono questioni di rilievo e in buona sostanza propongono l’abrogazione di leggi che a mio modesto avviso sarebbe giusto abrogare. Non entrerò nel merito delle questioni poste dai dodici quesiti, mi limiterò a segnalare che su due – l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e la responsabilità civile dei magistrati – abbiamo già votato e con esito che Labriola definirebbe «inutile» o «impotente». Tentar non nuoce, e forse neppure ritentare, ma – dicevamo – qui ci interessa solo la cosuccia, perché sul fatto che gli uomini che hanno in mano le leve dello Stato, «se vogliono, possono accettare il voto popolare, ma, se non vogliono, possono vittoriosamente resistervi», abbiamo già discusso nel post che ho citato all’inizio.
Un altro chiarimento necessario è relativo alle ragioni che portano a questa singolare congiunzione di astri nel firmamento della politica italiana. Ellittiche diverse, naturalmente, quelle di Pannella, di Grillo e di Berlusconi. Il primo è da almeno due decenni alla disperata ricerca di uscire dall’isolamento che peraltro ha ostinatamente cercato. Non è il caso di dilungarci troppo, su queste pagine la «cosa radicale» è stata oggetto di analisi in più occasioni. In breve, qui, possiamo limitarci a dire che lo strumento referendario era stato un po’ messo da parte dai radicali: costava energie sempre maggiori e dava risultati sempre minori. E tuttavia per Radicali Italiani, il soggetto della cosiddetta «galassia radicale» che negli ultimi anni è venuto a dar segni di sempre più manifesta insofferenza al settarismo di Pannella, il referendum è parso il solo tentativo possibile per rompere l’isolamento, e la scelta di sei temi sui quali i sondaggi danno da tempo il favore di larga parte dell’opinione pubblica nazionale è parsa la via più sicura. Non era quello che Pannella voleva. Trovandosi a dover accettare il fatto compiuto, ha aggiunto al pacchetto dei sei referendum promossi da Radicali Italiani quello suo, con altri sei referendum, su temi riguardanti la giustizia. Difficile capire se l’abbia fatto per riprendere il controllo dell’iniziativa politica della «galassia» neutralizzando le velleità di autonomia montanti in seno all’area, di fatto sta che i dodici quesiti referendari per i quali i radicali si stanno spendendo a raccogliere le firme si rivolgono a sensibilità che trovano congruità solo in un liberale: nella realtà italiana, che di liberale ha poco o niente, i primi sei chiamano a raccolta la sinistra e i secondi sei la destra.
Per Grillo il discorso è completamente diverso. Innanzitutto non è affatto certo che sapesse di cosa si trattasse quando il giornalista di Radio Radicale gli ha posto la questione. Attestato da sempre su posizioni giustizialiste, il M5S appoggia il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati o quello che pone maggiori limiti alla custodia cautelare? Bah, può darsi, di certo c’è soltanto che alla dichiarazione molto estemporanea, molto vaga e per nulla impegnativa non è seguito altro, al momento. Forte è il sospetto che Grillo fosse a conoscenza solo del primo pacchetto di quesiti referendari (abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, libertà di scelta nella destinazione dell’8xmille, introduzione del divorzio breve, abolizione della carcerazione per fatti di lieve entità relativi alle vigenti norme sugli stupefacenti, ecc.).
Diametricamente opposto il discorso per l’appoggio – attivo, in questo caso – annunciato da Berlusconi: è altamente improbabile che i suoi si impegneranno nella raccolta di firme per toccare i punti sensibili della Bossi-Fini o della Fini-Giovanardi, altamente improbabile che facciano uno sgarbo alla Cei su questioni come il divorzio breve e l’8xmille. Inutile sottolineare, inoltre, il senso strumentale che assume il suo appoggio alla campagna referendaria radicale per la «giustizia giusta» nel frangente che lo vede impegnato come mai prima nella difesa delle sue sorti di indagato e di condannato in attesa di sentenze definitive.
Se il lettore ha avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto, potrà essere indulgente con chi ha voluto solo tratteggiare per sommi capi le vie che portano i tre a questo assai malfermo accordo su gambe entrambe zoppe: l’intenzione non era quella di delineare lo scenario politico italiano dinanzi alle variabili poste dai referendum radicali, se mai si terranno, ma di tornare – come d’altronde era annunciato dal sottotitolo del post – alla critica sollevata da Labriola.
«Strumento di democrazia diretta», il referendum. Anche quando si dà come «correttivo» di una democrazia rappresentativa, tuttavia, non perde i caratteri che rendono pericolosa la democrazia diretta fatta sistema. Strumento, dunque, non solo «inutile» o «impotente», ma anche rischioso. E il rischio – se a questo punto non è superfluo aggiungerlo – è tutto a carico dei cittadini che, illudendosi di farsi legislatori in prima persona, non fanno altro che offrirsi, più o meno coscientemente, ai disegni di chi non si fa alcuno scrupolo nel «corbellare le masse».
Aggiornamento (15.7.2013) «Forte è il sospetto che Grillo...», dicevo. Sospetto ben fondato: fa sapere che non sapeva di cosa parlava e ritira il suo appoggio.
A scanso di equivoci, però, occorre qualche chiarimento. Quasi tutti i referendum di cui si sono fatti promotori i radicali pongono questioni di rilievo e in buona sostanza propongono l’abrogazione di leggi che a mio modesto avviso sarebbe giusto abrogare. Non entrerò nel merito delle questioni poste dai dodici quesiti, mi limiterò a segnalare che su due – l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e la responsabilità civile dei magistrati – abbiamo già votato e con esito che Labriola definirebbe «inutile» o «impotente». Tentar non nuoce, e forse neppure ritentare, ma – dicevamo – qui ci interessa solo la cosuccia, perché sul fatto che gli uomini che hanno in mano le leve dello Stato, «se vogliono, possono accettare il voto popolare, ma, se non vogliono, possono vittoriosamente resistervi», abbiamo già discusso nel post che ho citato all’inizio.
Un altro chiarimento necessario è relativo alle ragioni che portano a questa singolare congiunzione di astri nel firmamento della politica italiana. Ellittiche diverse, naturalmente, quelle di Pannella, di Grillo e di Berlusconi. Il primo è da almeno due decenni alla disperata ricerca di uscire dall’isolamento che peraltro ha ostinatamente cercato. Non è il caso di dilungarci troppo, su queste pagine la «cosa radicale» è stata oggetto di analisi in più occasioni. In breve, qui, possiamo limitarci a dire che lo strumento referendario era stato un po’ messo da parte dai radicali: costava energie sempre maggiori e dava risultati sempre minori. E tuttavia per Radicali Italiani, il soggetto della cosiddetta «galassia radicale» che negli ultimi anni è venuto a dar segni di sempre più manifesta insofferenza al settarismo di Pannella, il referendum è parso il solo tentativo possibile per rompere l’isolamento, e la scelta di sei temi sui quali i sondaggi danno da tempo il favore di larga parte dell’opinione pubblica nazionale è parsa la via più sicura. Non era quello che Pannella voleva. Trovandosi a dover accettare il fatto compiuto, ha aggiunto al pacchetto dei sei referendum promossi da Radicali Italiani quello suo, con altri sei referendum, su temi riguardanti la giustizia. Difficile capire se l’abbia fatto per riprendere il controllo dell’iniziativa politica della «galassia» neutralizzando le velleità di autonomia montanti in seno all’area, di fatto sta che i dodici quesiti referendari per i quali i radicali si stanno spendendo a raccogliere le firme si rivolgono a sensibilità che trovano congruità solo in un liberale: nella realtà italiana, che di liberale ha poco o niente, i primi sei chiamano a raccolta la sinistra e i secondi sei la destra.
Per Grillo il discorso è completamente diverso. Innanzitutto non è affatto certo che sapesse di cosa si trattasse quando il giornalista di Radio Radicale gli ha posto la questione. Attestato da sempre su posizioni giustizialiste, il M5S appoggia il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati o quello che pone maggiori limiti alla custodia cautelare? Bah, può darsi, di certo c’è soltanto che alla dichiarazione molto estemporanea, molto vaga e per nulla impegnativa non è seguito altro, al momento. Forte è il sospetto che Grillo fosse a conoscenza solo del primo pacchetto di quesiti referendari (abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, libertà di scelta nella destinazione dell’8xmille, introduzione del divorzio breve, abolizione della carcerazione per fatti di lieve entità relativi alle vigenti norme sugli stupefacenti, ecc.).
Diametricamente opposto il discorso per l’appoggio – attivo, in questo caso – annunciato da Berlusconi: è altamente improbabile che i suoi si impegneranno nella raccolta di firme per toccare i punti sensibili della Bossi-Fini o della Fini-Giovanardi, altamente improbabile che facciano uno sgarbo alla Cei su questioni come il divorzio breve e l’8xmille. Inutile sottolineare, inoltre, il senso strumentale che assume il suo appoggio alla campagna referendaria radicale per la «giustizia giusta» nel frangente che lo vede impegnato come mai prima nella difesa delle sue sorti di indagato e di condannato in attesa di sentenze definitive.
Se il lettore ha avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto, potrà essere indulgente con chi ha voluto solo tratteggiare per sommi capi le vie che portano i tre a questo assai malfermo accordo su gambe entrambe zoppe: l’intenzione non era quella di delineare lo scenario politico italiano dinanzi alle variabili poste dai referendum radicali, se mai si terranno, ma di tornare – come d’altronde era annunciato dal sottotitolo del post – alla critica sollevata da Labriola.
«Strumento di democrazia diretta», il referendum. Anche quando si dà come «correttivo» di una democrazia rappresentativa, tuttavia, non perde i caratteri che rendono pericolosa la democrazia diretta fatta sistema. Strumento, dunque, non solo «inutile» o «impotente», ma anche rischioso. E il rischio – se a questo punto non è superfluo aggiungerlo – è tutto a carico dei cittadini che, illudendosi di farsi legislatori in prima persona, non fanno altro che offrirsi, più o meno coscientemente, ai disegni di chi non si fa alcuno scrupolo nel «corbellare le masse».
Aggiornamento (15.7.2013) «Forte è il sospetto che Grillo...», dicevo. Sospetto ben fondato: fa sapere che non sapeva di cosa parlava e ritira il suo appoggio.
mercoledì 3 luglio 2013
«Legge Proust, dice che la politica non è affar suo»
Ho già
fatto un breve cenno al discorso che Giorgio Napolitano ha tenuto in
occasione del 60° della morte di Benedetto Croce (qui), oggi ne propongo alcuni
stralci, premettendo che l’approccio alla figura del filosofo è nel suo insieme
(qui) assai parziale: nulla sul suo pensiero, nulla sulla sua opera, e meno male, sennò sarebbe stato inevitabile qualche imbarazzo. No, tutto il
discorso è centrato sull’arco temporale che segue alla fuga di Croce da una
Napoli martoriata dai bombardamenti per riparare a Sorrento, e l’unica fonte
alla quale attinge Napolitano sono i diari vergati in quei mesi, prima che
anche Sorrento si rivelasse poco sicura e gli Alleati gli offrissero riparo a
Capri. Chi ha letto quelle pagine non ha potuto fare a meno di pensare che
fossero scritte per diventare pubbliche, e il malpensante avrà avuto il sospetto che servissero a nutrire ulteriormente l’automitobiografia
di uno che fu sempre molto attento a curare la propria immagine, un po’ per
vanità, un po’ per lasciarla in eredità alle figlie perché ne lucrassero. Ma
forse qui sarà il caso di lasciare la parola a Napolitano per valutare l’efficacia
di quelle pagine sul lettore ingenuo o – piacere – sul commemorante che si specchia nel commemorando.
Sarà. A me pare che bastino poche righe del diario
di Leo Longanesi a far collassare tutta questa schiuma retorica (Parliamo dell’elefante – Longanesi & C. 1947 – pag. 180).
martedì 2 luglio 2013
«Strumento di democrazia diretta»
1. «Quale
estensione intendono dare gli antiparlamentaristi al principio di legislazione
diretta ed in che modo intendono intrecciarla al funzionamento degli istituti
sociali, posto che l’organizzazione del governo, anche ridotto ad una macchina
che applichi le deliberazioni del popolo, non possa abbandonarsi al criterio
personale di alcuni uomini, sottratti ad ogni contatto popolare, per non far
essi parte di un’assemblea deliberante?». A porsi la domanda è Arturo Labriola
nel primo di tre articoli che uscirono su Critica Sociale nel 1897, in polemica
con «quanti propongono una organizzazione tale della legislazione diretta, per
mezzo della quale ogni traccia di governo parlamentare sia completamente tolta
via», al fine di eliminarne i guasti, «i quali, in verità, se si ammettono
tanto gravi e così rivoltanti, non possono eliminarsi se non con la più
radicale distruzione del sistema che vi dà organicamente origine». Polemica che
in generale era rivolta ai fautori della democrazia diretta, ma che nello specifico
aveva per oggetto uno dei suoi strumenti, quello della pratica referendaria:
Arturo Labriola vede nel referendum, laddove esso diventi uno strumento di
legislazione corrente, gli stessi pericoli che nella democrazia diretta sono
stati segnalati fin da Tucidide, e che in buona sostanza sono relativi al
rischio di imboccare quella che per Kant è «la via che porta al dispotismo». Dopo aver brevemente descritto il modello di democrazia diretta proposto da uno
dei suoi più convinti sostenitori, il quale teorizza un sistema legislativo
basato su un assemblearismo permanente che proprio nella pratica referendaria
trova il suo motore deliberativo, Labriola chiede: «Tralasciando obbiezioni che
faremo in seguito ed ammesso ciò che non sarà mai [...], sarebbe questo un modo
serio di far funzionare la macchina politica di un grande Stato? [...] Qui
occorrerebbe pensare ad una nazione la quale, anziché preoccuparsi della sua
vita materiale, stesse tutto il santo giorno nel foro ad ascoltare i
novellissimi Ciceroni pronti ad imbrogliarla non diversamente dagli antichi.
Ora, se tutto ciò era possibile nelle vecchie democrazie, che erano
organizzazioni di liberi divisi in classi fra loro egualmente sfruttanti il
lavoro degli schiavi [...], non lo è punto nelle democrazie moderne, fra le
quali si suppone che ciascuno abbia da procurarsi da sé stesso il proprio
sostentamento».
2. Volessimo portare i motivi della polemica di Labriola ai nostri
giorni, segnati da una rimontante infatuazione per la chimera della democrazia
diretta, potremmo chiederci: ma uno può stare tutto il santo giorno a studiare
ogni più minuto aspetto riguardante ogni più minuta questione relativa ai
problemi che esigono in fase deliberativa un parere adeguatamente informato?
Conosciamo la risposta di Gianroberto Casaleggio: la Rete darà vita ad una «realtà aumentata» nella quale il «cittadino» sarà trasformato in «istituzione»
acquisendo una «conoscenza superiore su qualunque aspetto». Risposta che non
convince: anche digitalizzato, il foro pullulerà sempre di Ciceroni. Volessimo,
poi, portare la polemica di Labriola ai nostri giorni per ciò che attiene alla
pratica referendaria, potremmo servirci di un esempio. Tra i dodici quesiti
referendari sui quali i radicali vanno raccogliendo le firme da qualche
settimana vi è quello che propone l’abolizione del finanziamento pubblico ai
partiti politici. Il testo del quesito (qui) è lungo 15.922 battute spazi inclusi. Ho
provato a dare una rappresentazione grafica alla scheda referendaria relativa a
questo quesito e la riproduco qui sotto.
Data
l’esperienza dei radicali in ordine alla presentazione di referendum alla
Corte Costituzionale, non vi è alcun dubbio che il quesito sia formulato in modo ineccepibile. Di più: tenuto conto di tutti i referendum proposti dai radicali e rigettati dalla Corte Costituzionale, direi che il quesito non potesse essere formulato diversamente. Ma la questione che esso pone mi pare sia evidente: quanti elettori lo leggeranno prima di sbarrare la casella di preferenza? Meglio ancora: pur leggendolo integralmente, quanti riuscirebbero a comprenderne «qualunque aspetto»? E tuttavia sulla lenzuolata si legge il titolo che riassume il senso del quesito: Abolizione del finanziamento pubblico ai
partiti politici, sì o no? Non vi è alcun dubbio che lo riassuma fedelmente, ma perché il dubbio sia fugato senza alcuna possibilità di riproporsi è indispensabile un minimo - anche solo un minimo - di fiducia in chi ha steso il quesito. Fiducia, si badi bene, che non è solo relativa alla sostanziale aderenza del testo al suo titolo, ma anche alla ineccepibilità formale indispensabile a rendere efficace la volontà espressa dal risultato della consultazione referendaria. Fiducia che fu riposta, in situazione del tutto analoga, col referendum sull’abolizione del finanziamento pubblico ai
partiti politici
che si tenne nel 1993, dove il sì ottenne il 90,1%. Sappiamo che della volontà popolare non si tenne alcun conto e possiamo imputare questo vero e proprio crimine alla capacità della casta partitocratica di aggirare
l’ostacolo posto dall’esito di quel referendum. Ma il punto è questo: il modo in cui era posto quel quesito non fu in grado di impedirlo.
E Labriola ci spiega come e perché: «In qualunque forma di società [...] la legislazione diretta è incapace, per sé sola, di corrispondere ai bisogni dell’amministrazione pubblica. Essa può immaginarsi come un correttivo del sistema parlamentare, non come un eliminatore. Ma qual correttivo è realmente efficace? Pur troppo, no; la legislazione diretta non esclude né la corruzione, né l’imbroglio, né il tradimento, e forse, sotto un certo aspetto, come mostrano le vecchie democrazie classiche, li fomenta. È almeno un mezzo rivoluzionario? Recisamente, no. La legislazione diretta o seconda la politica dominante, ed allora è inutile; o
l’avversa, ed allora è impotente. Nei sistemi in cui accanto alla legislazione diretta sta il parlamento, la forza militare dello Stato, il potere esecutivo e la burocrazia dipendono soltanto dalle Camere dei rappresentanti. Senza dubbio queste, se vogliono, possono accettare il voto popolare, ma, se non vogliono, possono vittoriosamente resistervi». Come dargli torto?
3. Con una delle sue felicissime uscite, qualche giorno fa, Massimo Bordin ha detto: «La
democrazia diretta si chiama così perché c’è sempre qualcuno che
la dirige» (Radio Radicale, 27.6.2013). Ben detto, così riassumendo due o tre scaffali di letteratura scettica, se non avversa, alla democrazia diretta. E tuttavia sarà il caso di rammentare che il referendum altro non è che «strumento di democrazia diretta»: correttivo inutile o impotente, se vogliamo riconoscere come fondate le riflessioni di Labriola. Prevengo la più scontata delle obiezioni, riprendendo la vulgata più comunemente evocata a fronte di questa critica sollevata al più decantato tra gli strumenti di democrazia diretta: ma il divorzio, l’aborto, non li dobbiamo ai referendum? Errore: li dobbiamo alle rispettive leggi licenziate dal parlamento, i referendum si limitarono a confermarle rigettando la proposta di abrogarle.
domenica 30 giugno 2013
«Fai tu»
L’Italia
dei Valori è a congresso e domani voterà per scegliere il segretario nazionale
tra cinque candidati (Ignazio Messina, Niccolò Rinaldi, Antonio Borghesi, Matteo Castellarin e Nicola Scalera). Sarà eletto Ignazio Messina, Antonio Di Pietro l’ha
deciso fin da un mese fa.
sabato 29 giugno 2013
Abbandoniamoci all’istinto
D’istinto
siamo portati a rigettare affermazioni fatte da individui che consideriamo repellenti.
Accade per risparmiarci la fatica di verificare ogni volta se ci sia la stretta
associazione tra chi parla e ciò che dice, dopo averla riscontrata in un numero
più o meno consistente di occasioni. È umano, ma è sbagliato. Per meglio dire,
si tratta di un errore argomentativo: quello detto «ad hominem». Bene, vedo che
si commette questo errore con ciò che Mario Adinolfi ha scritto in Perché sono contrario al matrimonio gay (*): nessuno si accolla la fatica di leggere il post, di rilevare le innumerevoli fallacies di cui è infarcito (ricorso all’autorità, ricorso alla tradizione, ricorso a una credenza,
ricorso alle conseguenze di una credenza, ricorso alla pratica comune, ricorso all’emozione, ricorso alla petizione di principio, ricorso alla nitidezza fuorviante, ricorso all’analogia del pendio scivoloso, ecc.), nessuno prova a dimostrare in modo circostanziato perché sia una merda. Niente, lo si dà per scontato: ciò che ha scritto viene rigettato perché è una merda a priori, e questo onestamente è sommamente ingiusto. Ecco perché mi sento in obbligo di mettere da parte per un istante le Noctes Atticae di Aulo Gellio, nelle quali stasera mi ero rifugiato per evitare
l’ennesimo Santoro sul caso Ruby, nel tentativo di dimostrare che, nel caso, merda sì, ma solo a posteriori. E dunque...
«Con la
sentenza della Corte Suprema Usa (per carità, è solo un primo passo, ma la
pallina ormai è su un piano inclinato) il matrimonio gay, già sdoganato in
mezza Europa, si appresta a diventare tema di dibattito anche in Italia e prima
o poi legge. Mi rendo conto dell’impopolarità della mia posizione, in
particolare a sinistra dove comunque ricordo la linea del Pd è contrario al
matrimonio omosessuale e a favore delle unioni civili “alla tedesca” (linea su
cui concordo in pieno), ma io sono stato sempre e resto contrario alle nozze
gay. Provo a riassumere il perché in cinque rapidi motivi».
Sorvoliamo
sulla forma sgangherata data al secondo periodo, limitiamoci a considerare
quella che in premessa sembra avere la pretesa di chiarire la posizione
politico-culturale di chi prende la parola, dandole un valore di coerenza che dovrebbe bastare a renderla qualificata se comparata a quella del Pd, che invece darebbe prova di incoerenza. Si tratta di un tentativo di slittamento dei piani di contesto, col quale Mario Adinolfi prova ad accreditarsi come fedele a posizioni che il Pd avrebbe abbandonato o sarebbe in procinto di abbandonare: fa affidamento sulla capacità di lasciar credere che tra le ragioni per le quali è uscito dal Pd ci sarebbe anche il mutato atteggiamento del partito sul matrimonio gay. In pratica, sarebbe il Pd ad essersi spostato, lasciandolo fuori, saldo sulle sue posizioni, che così acquisterebbero un sovrappiù di valore: prim’ancora di esporle e argomentarle, Mario Adinolfi ci chiede un anticipo di favore, che gli sarebbe dovuto perché resiste al gorgo del mainstream che ha inghiottito il Pd. E qui si ha un ulteriore tentativo di slittamento dei piani contesto:
l’opposizione al matrimonio gay è suggerita come posizione anticonformista. Cosa aggiunga o cosa tolga forza ad una affermazione se conforme o no all’opinione corrente, non è dato comprenderlo. Cosa aggiunga o cosa tolga solidità agli argomenti coi quali si intende supportarla se la si è sostenuta da sempre mentre altri la abbandonavano, men che meno. Si può solo ipotizzare che con questo post Mario Adinolfi stia provando a rientrare nel Pd grazie all’interessamento di chi nel partito rimane contrario al matrimonio gay.
«1. Per
me il matrimonio è l’unione tra un uomo e una donna, questo è stato per
millenni. Dal matrimonio derivano diritti e doveri. La battaglia per il
matrimonio omosessuale non è una battaglia per una parolina (chiamarla “matrimonio”
o “pippo” cosa cambierebbe?) è la battaglia per i diritti che ne conseguono. I
tre fondamentali temi di controversia sono il diritto “a formarsi una famiglia”,
il diritto di successione e il diritto alla reversibilità della pensione. Sono
due diritti che io contesto possano essere riconosciuti fuori dal matrimonio
tra un uomo e una donna».
Anche qui sarà il caso di sorvolare sulla forma, che peraltro rende problematica la comprensione di quali siano i
«due diritti»
contestati sui «tre» indicati, anche se al fine di rilevare la fragilità dell’impianto argomentativo costituisce dato irrilevante (tuttavia da quanto segue si ricava che «due» sia un refuso). Quello che appare ben chiaro, invece, è il ricorso alla tradizione come fonte di autorità dirimente senza appello. Si potrebbe fare altrettanto in difesa della schiavitù, se non fosse stata già abolita in gran parte del mondo. D’altronde, chi si batteva contro la sua abolizione dava enorme peso al fatto che «questo è stato per millenni». Ma il cortocircuito logico sta altrove: da un lato, infatti, si afferma che la questione non è meramente nominalistica («non è una battaglia per una parolina») e, dall’altro, come vedremo al punto 2, sembra che essa stia tutta nel nome da dare al
«vincolo»
che viene a crearsi in un
«rapporto “stabile”» tra due individui che abbiano lo stesso sesso («Se
rompiamo la sacralità del vincolo matrimoniale tra uomo e donna, ogni rapporto “stabile”
potrà alla lunga trasformarsi in matrimonio»). È come se per la radice pater- che in patrimonio si sollevasse obiezione al diritto di possedere un bene materiale se esercitato da una donna: si tratta di paradosso, ma, come vedremo, è proprio ciò che Mario Adinolfi ritiene legittimo per la radice mater- che sta in matrimonio.
«2. Se
il matrimonio è solo un timbro pubblico sul proprio amore e “davanti all’amore
lo Stato non può imporre a nessuno come comportarsi”, al momento dovessimo
ammettere la rottura del principio sacro per millenni che il matrimonio è l’unione
tra un uomo e una donna, perché limitarci a rendere legale e matrimoniale solo
il rapporto tra due donne o due uomini? Perché non accettare che ci si possa
amare in tre? O in quattro? Se un bambino riceve amore uguale a quello di una
madre e di un padre da due papà, perché non da quattro? O da tre papà e una
mamma? O dal papà che ama tanto il proprio cane e vuole che la sua famiglia sia
composta dal papà, dal cane e dal bambino ottenuto da una madre surrogata? Il
cane dimostra tanto affetto verso il bimbo, quasi gli somiglia. Se rompiamo la
sacralità del vincolo matrimoniale tra uomo e donna, ogni rapporto “stabile” potrà
alla lunga trasformarsi in matrimonio, sarà un diritto incontestabile. Con
conseguenze inimmaginabili».
Qui comincia a venir meno la motivazione all’analisi del testo, perché comincia a farsi forte il sospetto che si voglia sollevare obiezione al matrimonio gay assimilandolo a tutto ciò che non sia matrimonio tra un uomo e una donna. Sul piano logico è operazione legittima solo dopo aver assunto che l’unico vincolo degno di essere considerato matrimoniale sia quello tra due persone di sesso differente. In altri termini, è come se per sollevare obiezione al diritto di sciopero bastasse porre la domanda retorica: «Ti par bello che i ciliegi smettano di fiorire in primavera?». A chi la ponesse, basterebbe di rimando chiedere: «Scusa, ma che cazzo c’entra?». Poi, avendo tanta pazienza, si potrebbe anche perder tempo a spiegare la differenza tra un lavoratore e un albero da frutta. Così con Mario Adinolfi, spiegandogli la differenza tra genere e numero, e facendogli presente che un cane non ha capacità giuridica.
«3. Se
due uomini possono sposarsi ne deriva il pieno diritto a “formarsi una
famiglia”. Senza limitarsi al diritto all’adozione, no, quello è il meno.
I precedenti ci dicono che il diritto a figliare forzando la natura sarà
pienamente tutelato. Il caso più noto è quello di Elton John e di suo “marito”
David. Sono decine di migliaia già i casi similari. Elton e David vogliono un
figlio. La natura pone un limite a questo loro bisogno, come è noto. Ma Elton e
David vogliono, fortissimamente vogliono. Sono sposati e ora come tutte le
coppie vogliono un figlio. Allora affittano (Dio mio, faccio fatica persino a
scriverlo) l’utero di una donna, mescolano il loro sperma e con quel mix la
ingravidano, nasce il piccolo Zac che appena nato istintivamente viene posato
sul ventre della madre e naturalmente cerca il suo seno. Zac viene però
immediatamente staccato a forza da quel suo rifugio naturale e consegnato ai “genitori”.
Il bimbo per un anno intero non fa altro che piangere, Elton se ne lamenta
graziosamente in qualche intervista e racconta che per placarlo faceva “tirare”
il latte al seno della madre naturale per allattarlo poi con il biberon. Io l’ho
trovata una storia agghiacciante, una violenza terribile fatta al più debole
tra gli umani, il neonato. La moda imperante considera tutto questo invece
molto glamour».
Qui, francamente, si è fortemente tentati di essere indulgenti con l’errore argomentativo «ad hominem», perché dinanzi a un così palese tentativo di spostare la discussione dal matrimonio gay al diritto di allevare prole da parte di una coppia gay, e dal
diritto di allevare prole da parte di una coppia gay alla possibilità di affittare un utero, e dalla possibilità di affittare un utero al far piangere un bambino, e dal far piangere un bambino all’agghiacciare Mario Adinolfi, e dal suo agghiacciarsi a quello di chi dovrebbe agghiacciarsi all’idea che due gay possano sposarsi, c’è solo da chiedersi chi possa mai fottersene di sentirsi intellettualmente a posto nel dargli della merda solo se a posteriori. Lasciamo perdere, via, abbandoniamoci all’istinto.
venerdì 28 giugno 2013
Il mito
Pare che la signora Ferrara, parlando del marito,
abbia detto: «Legge Travaglio, lo fa sempre. Quando lo insulta, serve a far
crescere il mito di Giuliano» (La Zanzara - Radio24, 28.6.2013). Ora, io non so come immaginate voi la scenetta
domestica, io la immagino così. Ferrara seduto sulla tazza del cesso con Il
Fatto Quotidiano in mano, tre quarti di natica che strabordano di qua, tre
quarti dell’altra natica che strabordano di là, tazzina di caffè appoggiata sul
bordo del bidet, pacchetto di sigarette e accendino appoggiate sul lavandino: «Selma,
Travaglio m’insulta pure oggi». E Selma: «Bene, tesoro, così ti cresce il mito». Non so
voi, a me viene una tristezza, ma una tristezza…
Presto!
S’era
diffusa voce che tre francescani fossero stati decapitati in Siria da un gruppo
di feroci jihadisti. Non era vero. Peccato, perché bilanciava a meraviglia la
notizia dell’arresto di monsignor Scarano, fino a ieri funzionario dello Ior,
villone da favola stracolmo di preziose opere d’arte, accusato di truffa,
ricettazione e riciclaggio. Fosse stato vero, fossero stati sei invece che tre,
si sarebbe pareggiato il conto pure con le rivelazioni di don Poggi sul giro di
prostituzione maschile in Vaticano, festini incandescenti con ragazzini rumeni
raccattati alla Stazione Termini, marchette da 400-500 euro e cosacce del
genere. I tre francescani sono vivi, maledizione. Presto, c’è mica qualche
madonnina che pianga sangue o qualche reliquia che risvegli il comatoso?
«Sfogatoi virtuali»
Un box
a pag. 33 de la Repubblica di giovedì 27 giugno mi offre l’occasione di intrattenermi
su una questione che avrei voluto affrontare già da tempo. Questione rilevante,
per un blogger, quella della «fine dei blog», ma, ogni volta che mi accingevo a
trattarla, d’un tratto mi
appariva frivola o comunque a rischio di scivolare, da un lato, nell’autoreferenzialità
e, dall’altro, nel tecnicismo. In buona sostanza, il rischio era quello di
affrontare la questione eludendo il suo aspetto più importante, che a mio
parere è centrale e ineludibile: quello relativo alle ragioni che spingono a
mettere in rete (web) un diario (log). Senza far chiarezza su cosa sia un log,
e quale carattere assuma quando dal taccuino privato passa al web, ogni
discussione sulla blogosfera diventa un ginepraio di fraintendimenti. Un diario
è una raccolta di scritti relativi a cose o fatti che sono in stretta relazione
all’autore: non ha importanza quale sia la natura dei temi trattati, quale sia lo
stile scelto per trattarli o quale sia la frequenza delle pubblicazioni, l’aspetto
peculiare è il carattere personale della scrittura, di là dagli elementi che ne
consentono un giudizio di merito. Cerco di
dirlo meglio: ciò che caratterizza un blog rendendolo differente da una
qualsiasi altra pagina pubblicata online è un io narrante che, anche quando è dissimulato
in un tu o in un noi che sono meri espedienti retorici, fa della scrittura un
momento di intermediazione tra pubblico e privato. Ma forse anche così non è
abbastanza chiaro, e sarà meglio che ricorra a qualche esempio.
Prendiamo
la classifica di BlogBabel e cominciamo a scorrerla. Il blog di Beppe Grillo è
un blog? Assolutamente no: è un’agorà telematica. Il Post o Giornalettismo?
Certamente no: sono giornali online. La ventisettesima ora o Tvblog? Manco per
niente: sono dei magazine. Manteblog e Piovono rane? Sono blog: hanno un io
narrante, la periodizzazione della scrittura risponde a un’esigenza personale,
l’intermediazione tra pubblico e privato ricorre a un metatesto che ha
articolazione diaristica. Arrivo a fine a pagina e tra le prime 100 testate in
classifica non conto più di 20 blog. Se gli altri 80 chiudessero le loro
pubblicazioni, potremmo dire che la blogosfera ha subìto un collasso? A mio
modesto avviso, no.
Se ne
parla da almeno due o tre anni, e il giudizio pressoché unanime è che la crisi
della blogosfera sia in larga misura da imputare ai social network, in primo
luogo a Facebook e a Twitter, che offrirebbero il vantaggio di una più
immediata interattività. Ecco, fin da questo primo dato, d’altronde
incontestabile se avulso da ogni considerazione sul tenore di interattività relativa
al mezzo, a me pare che si commetta l’errore di ascrivere al volume della
blogosfera di qualche anno fa molto di quanto non le appartenesse davvero. In altri
termini, io credo che molti di quelli che erano considerati blog, e formalmente
lo erano, in realtà non lo fossero: erano embrioni di homepage di Facebook o di
Twitter, che aspettavano di venire alla luce. Dirò di più: una discreta quota
di «scrittura da social network» era già presente anche nei blog che almeno formalmente
erano tali, e questo, a mio parere, spiega perché anche i blogger
ancora attivi hanno ridotto più o meno drasticamente la loro produzione, trovando
nella parallela attività sui social network il fisiologico drenaggio di quanto
prima postavano sui propri blog. Mi pare che una conferma sia nella contrazione
del numero dei commenti ai post e dei link che rimandano ad altri post: non
sapevo se si trattasse solo di una mia impressione, ma ne ho trovato riscontro
in qualche studio ampiamente documentato. È che il chiacchiericcio che prima
affollava le pagine dei commenti, non di rado assai sterilmente, si è
trasferito nel suo luogo d’elezione, che è la piazza dei social network, mentre
il link si trasformato in like o in retweet.
A
questa «fine dei blog», insomma, io non credo molto: penso piuttosto che la blogosfera
vada scremandosi della superflua schiuma che ne ingrossava il volume da
sovranatante. Poi, sì, ci sarà pure chi non ha più niente da dire dopo aver detto tutto quello che aveva da dire, ci sarà chi avrà pensato al blog come alla vetrina nella quale esporsi per trovare un acquirente e deluso ha chiuso bottega, ci sarà chi si è sposato, ha fatto figli, ha cominciato a lavorare e non ha più trovato tempo. E tuttavia è indubbio che ci sia ricambio. Qui la blogosfera si contrae, lì si espande.
A parte Di Angelo Acquaro so poco, e quel poco è quanto ho origliato dagli aficionados de la Repubblica, che di solito sono assai teneri con tutte le firme del giornale, ma con lui vedo sono assai duri: se devo esprimere un parere personale sulla base di ciò che leggo nel suo box, è durezza meritata. Angelo Acquaro è superficiale, ha scrittura sciatta, rimastica luoghi comuni, partorisce espressioni di incredibile volgarità come «sfogatoi virtuali», che sono anche al di sotto del livello di una Soncini prima della ripulitina.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)