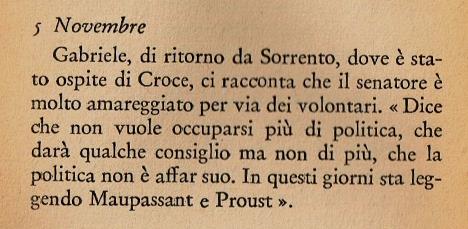Tommaso Labate ci offre l’occasione
di affrontare una questione assai delicata sul piano morale, per certi versi
affine a quella che si pone quando muore un pezzo di merda: rimane il pezzo di
merda che era o si deve chiudere un occhio, cioè una narice? Se in quel caso pare debba
prevalere il «nisi bonum de mortuis», qui Labate sembra voglia consigliarci la
solidarietà umana nei confronti del condannato, anche quando la condanna sia per
reati abietti. E non si limita a dissuaderci dal maramaldeggiare, sia chiaro, ci
suggerisce proprio la solidarietà umana o, in subordine, un po’ d’indulgenza
alla sua solidarietà umana nei confronti del pezzo di merda.
«Dalle parti mie
– scrive – c’era tanti anni fa un uomo molto potente e in odore di massoneria. Un
uomo perennemente circondato da un inimmaginabile codazzo di gente, gente
povera e gente ricchissima, a cui verosimilmente elargiva nel primo caso elemosine,
nel secondo favori un po’ più consistenti». Qui è opportuno fermarci un attimo per
cercare di dare contorni più netti a questo personaggio. Labate è nato nel 1979
a Marina di Gioiosa Jonica, un paesino di poco più di 6.000 anime, in provincia
di Reggio Calabria, che da almeno 40 anni è in mano a due ’ndrine, quella dei Mazzaferro
e quella degli Aquino, che si contendono da sempre, a suon di morti ammazzati, un
imponente giro di malaffare (estorsione, usura e traffico di stupefacenti) con
tentacoli ben radicati in Lombardia, in Liguria, in Germania e in Belgio. Che
tipo di profilo assume, in un contesto del genere, un personaggio descritto
come «un uomo molto potente»? È azzardato dedurre che si trattasse di Vincenzo
Mazzaferro o di Salvatore Aquino? E perché Labate dice che era «in odore di
massoneria» e non fa alcun cenno alla ’ndrangheta? Una mezza idea ce l’ho, ma
la esporrò alla fine, d’intanto chiariamo che tra esponenti della famiglia
Mazzaferro e la massoneria deviata sono documentati legami tra gli ultimi anni ’80
e gran parte degli anni ’90.
«Ero bambino – prosegue Labate – ma ricordo come
se fosse oggi il disprezzo, il distacco umano e la profonda antipatia che mio
padre nutriva nei confronti di questa persona. Come a dire, “neanche un caffè”.
Una volta, però, questo signore
finì in una clamorosa inchiesta della magistratura che ne azzerò in un colpo
solo la mastodontica corte di leccapiedi e pure il potere». Si tratta dell’operazione
«Leopardo» (1992) o dell’operazione «Fiori della notte di San Vito» (1994)? Non
ha importanza, in fondo. Proseguiamo nel racconto di Labate: «La sera della
prima vigilia di Natale da quel tracollo, ma questo l’avrei saputo dopo, mio
papà – che con lui, prima, “neanche un caffè” – comprò una bottiglia di
champagne e andò a trovarlo per gli auguri. Immaginava una scena, mio papà. E
infatti se la ritrovò davanti proprio come l’aveva pensata. Di fronte a quel
portone in cui nelle precedenti vigilie di Natale la gente s’accalcava, non c’era
più nessuno. Manco un’anima. Nessuno. Solo mio papà. E la sua bottiglia di
champagne. Su quella persona mio papà non ha mai cambiato il suo giudizio
precedente. E penso che, dopo quella volta, non si rividero più».
Qui, alla
luce di ciò che Labate ha omesso, è superfluo ogni commento. «Non c’era più
nessuno», ma in causa si deve chiamare solo l’umana ingratitudine? Nessuna attenuante
per l’«inimmaginabile codazzo di gente» che prima circondava l’«uomo molto
potente»? Diamo per scontato che tutti sapessero da sempre chi fosse, che genere di affari trattasse, e che solo «mio papà» fosse da sempre riuscito ad avere nei suoi confronti un atteggiamento moralmente ineccepibile:
ma fu solo l’umana ingratitudine a fare il deserto «di fronte a quel portone»?
Sul piano morale possiamo condannare un cliens che abbia paura di essere
considerato socius dalle forze dell’ordine che sorvegliano l’abitazione dell’indagato?
Chi può permettersi di andare a stappare una bottiglia di champagne con lui?
Solo chi non è mai stato cliens, è evidente. Rimane tuttavia da stabilire se un
tal gesto di solidarietà con chi sia caduto in disgrazia possa essere
giustificato di là dai motivi che hanno provocato la caduta. «In odore di
massoneria», forse. Ma reo di crimini odiosi?
Labate scrive: «Io so che a
tutti quelli che certe volte sbarrano gli occhi e mi chiedono “come c...o sei
fatto?” e “che cos’hai nella testa?” vorrei raccontare questa storia. Quest’insegnamento
che ho preso e che non dimenticherò mai. Questa cosa di mio padre che avrei
fatto nello stesso identico modo. E che rifarei di fronte a un portone deserto
davanti a cui prima si accalcavano le masse, che rifarei alla vigilia di
Natale, che rifarei comprando una bottiglia di champagne, che rifarei pur
conservando intatto il giudizio precedente sul Re corrotto e osannato, poi
caduto e abbandonato. Che rifarei si chiami esso Mario Rossi, Giuseppe Verdi o
Silvio Berlusconi».
Non avevate immaginato dove volesse andare a parare? Siete
degli ingenui, bastava sentire come montava il climax. Via, tutti a Palazzo
Grazioli, a Natale. Tutti con una bottiglia di champagne. In cambio, poi,
Labate ci fa il favore di dirci nome e cognome del tizio col quale brindò suo
papà. Era Mario Rossi? Era Giuseppe Verdi?