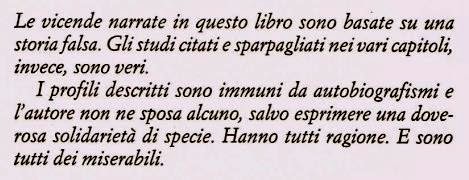Al
pari di ogni altro strumento, anche la parola muta nel tempo la specifica funzione
per la quale è stata creata per l’ampliarsi o il ridursi delle occasioni in cui
ne è richiesto l’uso. Così è per la vis
che sta in violentus, dove l’-olentus è quasi pleonastico ad indicare
l’eccesso di energia. A differenza della fortia,
infatti, che si esprime nella capacità di sostenere un peso e di resistere ad
una spinta, e perciò trova sinonimo nella solidità e nella fermezza che
implicano uno sforzo isometrico, la vis
è eminentemente dinamica, sicché la violenza
non sta in una forza che sia solo «soverchia,
[ma che sia pure necessariamente] messa
in moto» (Niccolò Tommaseo), per lo più nell’impeto di un attacco potenzialmente
distruttivo di tutto ciò che le si oppone.
Ciò detto, come altrimenti che
violenta potremmo definire la fede che si dà mandato di far trionfare una
verità su tutte? Non si ha, questo trionfo, senza che ogni altra verità venga distrutta
riducendola a menzogna, e questo rende ineluttabilmente violento il mezzo
efficace al conseguimento di tal fine, anche quando è dichiarato esclusivamente
persuasivo.
Si prenda il Corano: «Non v’è
costrizione nella religione, giacché la retta via ben si distingue dall’errore»
(2, 256); «Se Dio volesse, tutti
crederebbero in Lui. Tu pensi sia necessario costringerli?» (10, 99); «A chi porta la parola di Dio spetta solo il
trasmetterla» (5, 99). Si tratta di versetti che solo in apparenza
contraddicono i tratti dell’jihad che si fa truculento quando da lotta
interiore per raggiungere il perfetto grado della fede diventa guerra santa
contro gli infedeli, perché il dinamismo della vis proselitaria è sempre per sua natura pleomorfo e opportunista.
Si pensi al Manuele II Paleologo caro a Ratzinger: afferma che «chi vuole condurre qualcuno alla fede ha
bisogno della capacità di parlare bene e di ragionare correttamente, non invece
della violenza» (Dialoghi con un persiano,
VII, 93), ma nella storia del cristianesimo questo sta senza eccessivo
imbarazzo accanto ai battesimi forzati di ebrei, indios e neonati.
Tutto sta,
in fondo, nella forma che assume la violenza e nella sensibilità a coglierla
quando è dissimulata. Così, mentre si preferisce definire «guerra santa» la
catena degli eventi che scuotono il mondo islamico, dimentichiamo che tra
qualche mese ricorre il 15° anniversario della Dichiarazione «Dominus Iesus» della Congregazione per
la Dottrina della Fede, riaffermazione della legittimità della vis proselitaria che la Chiesa di Roma
non ha mai rinunciato a esercitare al fine di estendere κατά όλος il suo credo, giacché la sua missione non si esaurisce
nell’annuncio evangelico, ma nell’«instaurarlo
tra tutte le genti» (18).
Certo, «al
termine del secondo millennio cristiano questa missione è ancora lontana dal
suo compimento» (2), per giunta certi strumenti del passato sono diventati
inutilizzabili. Si pensi a come, per secoli, colonialismo ed evangelizzazione sono
andati a braccetto e si prenda atto che non è più possibile: occorre che la vis perda il dinamismo
della conquista militare e potenzi il carattere isometrico della fortia che resiste alla conquista
militare dei competitori.
«Circa il modo
in cui la grazia salvifica di Dio […] [possa] arriva[re con profitto] ai
singoli non cristiani [in queste mutate condizioni storiche]» (21), occorre
constatare che le cose si son fatte assai più difficili: giocoforza si deve ripiegare
sul dialogo, ma senza dimenticare che «la
parità, presupposto del dialogo, si riferisce alla pari dignità personale delle
parti, non ai contenuti dottrinali» (22). Siamo alla constatazione che «lavorare per il Regno vuol dire riconoscere
e favorire il dinamismo divino», ma che i tempi costringono al sospiro del «vorrei ma non posso». Poi, come sempre, ci si può far prendere dall’abbrivio, e allora si può arrivare a bestialità del tipo «la Chiesa non fa proselitismo» (Ratzinger, 13.7.2007).