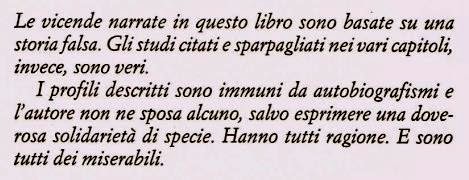La
durata media di un intervento pubblico di Sergio Mattarella nell’arco temporale
preso in oggetto (crf. Mattarelliana / 1) è di 21'09", bassa se rapportata
alla prolissità dei politici della Prima Repubblica, bassissima se rapportata a
quella degli esponenti della Sinistra democristiana. Almeno per la parte fin
qui trattata (1986-1989), sono anni in cui l’intervento pubblico di un politico,
soprattutto se democristiano, ha i tratti tipici della retorica largamente
impiegata nella Prima Repubblica: periodi lunghi e infarciti di proposizioni
secondarie, insistito uso della perifrasi, costante ricorso all’eufemismo e,
soprattutto, come carattere che a mio modesto avviso può essere considerato tra
i più significativi del fine ultimo cui si consegna il discorso, tendenza a
bilanciare ogni asserzione con tutti i «benché», i «sebbene» e i «purtuttavia»
sui quali esso intende dimostrarsi rettamente validato per un’onesta
ponderazione. Sergio Mattarella non è un caposcuola di questa retorica, né si
contraddistingue per una di quelle singolarità di stile che pure sono
rintracciabili nell’uniformità del discorso data dai suddetti caratteri: è un
retore minore, non brilla per incisività, non ha coloriture degne di nota, in
più è penalizzato da un eloquio poco fluido, da una dizione che sembra subire
un’urgenza di affrettarsi e che costantemente lo induce a microfratture che
sacrificano per lo più le sillabe finali delle bisdrucciole. Anche sui
contenuti, niente di notevole: è il caratteristico esponente della sinistra
democristiana che declina come meglio può, e meglio sa, la Dottrina Sociale
della Chiesa, meno vibratile di una Rosy Bindi, senza i cromatismi di un
Pierluigi Castagnetti, ma soprattutto assai al di sotto della versatilità di un
Leopoldo Elia o di un Nino Andreatta. E tuttavia c’è un punto, che a me pare di
poter datare tra il 1990 e il 1991, in cui si evidenzia uno scarto di un certo
significato, oltre il quale rimane retore minore, ma acquistando un peso
polemico: non è Sergio Mattarella a diventare meno opaco, ma è il contesto in
cui i suoi interventi pubblici vanno a calare a renderlo più incisivo, almeno per
l’uditorio del momento. Sono gli anni in cui monta il malcontento del paese
contro il malcostume dei partiti e la Dc, com’è ovvio per un partito che è al
governo da quasi mezzo secolo, è tra quelli maggiormente fatti oggetto di una
critica che spesso assume i toni dell’aggressione. La reazione è quella
dell’arroccamento, d’altronde già adottata in passato (si pensi al «non ci
faremo processare nelle piazze» di Aldo Moro), ma i tempi ormai sono cambiati e
il sistema manda sinistri scricchiolii che annunciano la prossima implosione.
Sergio Mattarella, qui, mostra le energie di chi è in politica da nemmeno dieci
anni, e dunque non dà per acquisite le rendite di posizione: insiste sulla
necessità di un rinnovamento della Dc, che deve riscoprirsi partito popolare,
abbandonando gli intrecci col malaffare e riguadagnando il credito che la rese
centrale nel paese. Pochi anni prima sarebbe stata una proposta da anima bella,
nel 1991 diventa un posto da vicesegretario. Ed è proprio nel 1991, ad un
convegno su Crisi del sistema politico e ruolo dei partiti, tenuto a Chianciano,
il 18 ottobre, che in uno dei suoi discorsi più lunghi (56'11") Sergio
Mattarella si offre in una summa. L’eloquio ha un tratto che gli conferisce un
piglio spiccio e sbrigativo, mentre i contenuti, e perfino certi passaggi,
certi modi di dire, certe formule sintattiche, sono i soliti.
Quello
non è un gretto incontro di corrente, dice. Se appena l’anno prima la sinistra
democristiana era una forza di opposizione, oggi è guida, almeno come
patrimonio di valori tutti intatti, e si fa carico delle istanze di tutto il
partito, anche se ci sono rigurgiti della posizione che fu a lungo maggioritaria
per mettere la sinistra in una «riserva indiana». I tempi cambiano, e cambiano velocemente:
accade quello che si pensava non sarebbe mai potuto accadere, e non solo per la
caduta del comunismo, non solo per il riaccendersi nel mondo di focolai di
guerra che ci mettono un niente ad allargarsi (il Golfo Persico, i Balcani), ma
anche per una «forte messa in discussione della centralità della Dc», e quando s’era
visto mai, puttana Eva. Il cittadino è cambiato: è un concentrato di delusione
e attesa, di sfiducia nel passato e di un bisogno di rinnovamento morale che lo
spinge ad atteggiamenti demolitori. I nodi vengono al pettine, e uno riguarda
la Dc, come partito dei cattolici. La questione non è quella dell’unità
politica dei cattolici, l’ha detto il Papa a Loreto, l’ha detto Ruini nell’ultima
prolusione, ma delle ragioni storiche di una classe politica che si ispira alla
Dottrina Sociale della Chiesa, giacché nessuno ha scelto di essere democristiano
per un altro motivo. Viene meno il Pci, almeno nel nome, che sembra poco ma è
più di molto, però questo non deve in alcun modo significare che vengano meno
le ragioni della Dc, cui spetta ribadire il suo ruolo di promozione del rispetto
della persona umana e a tutela dei più deboli. Ridare corpo al popolarismo,
come coinvolgimento della società che crede nel processo di perfezionamento
della «città dell’uomo», nella quale l’uomo non potrà mai realizzarsi pienamente
(sottinteso: questo potrà accadere solo nella «città di Dio»), senza perciò
dover rinunciare a renderla più vivibile. Questa è la dimensione della laicità
sulla quale insiste: il temporale è autonomo, ma non può non guardare al
magistero della Chiesa, che qui si è da poco rinnovato nella Centesimus Annus,
che cent’anni dopo la Rerum novarum rideclina la terza via tra capitalismo e
socialismo, offrendo un compromesso inservibile. D’intanto, tutto d’attorno è bufera. Si fa strada – dice
– un modo di far politica che consiste nella denigrazione dell’avversario,
mentre l’opinione pubblica mostra un’urgenza di una condanna di tutto e di
tutti, come per una palingenesi che non risparmi nulla. E i partiti hanno le
loro colpe, e le élites finanziarie pure, e il potere per il potere porta al
peggio, e contro il popolarismo c’è solo il plebiscitarismo, e certo sbranarci
di tra di noi non reca alcun vantaggio: cose così, con continui richiami alla
Cei. E una democrazia senza valori equivale ad un totalitarismo subdolo, e la
classe politica si è chiusa man mano che aumentava la voglia di partecipare, e
la forma di partito è superata, e sì alle privatizzazioni, ma non si può
demolire il patrimonio pubblico: cose così, e l’uditorio applaude.
L’anno
dopo, alla Festa dell’Amicizia che si tiene a Pesaro, più che un anno, sembra
passato un secolo: Mani pulite ha scoperchiato la fogna e Sergio Mattarella può
lamentare che s’è perso un anno. Non presente che la Dc è ormai agonizzante, ma
già è pronto per diventare il custode di un pezzo della reliquia. Non si sa mai, dovesse tornar comodo.
[segue]