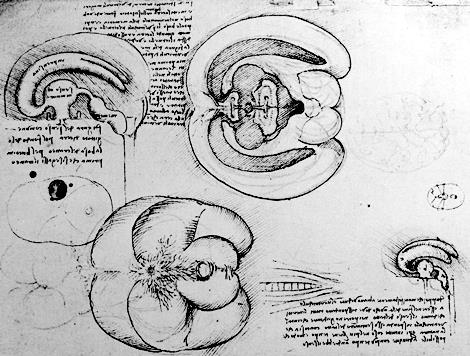Solitamente
la fortuna di un neologismo si è sempre misurata sull’ampiezza
e sulla durata che il suo impiego riusciva a conquistare, sicché
in passato trovava registrazione solo dopo aver adeguatamente
consolidato la sua posizione nel linguaggio corrente. Si pensi, per
esempio, a «nostalgia», termine coniato
nel 1688, che deve tuttavia attendere più di un secolo per
essere trovato sulle pagine di un dizionario.
Di
pari passo a una percezione del tempo e dello spazio che si andava
sempre più rapidamente evolvendo rispetto a quella del passato, la
fortuna di un neologismo è venuta sempre più spesso a misurarsi
sulla velocità e la forza con le quali se ne diffondeva l’uso,
al punto da convincere anche i più sussiegosi difensori della
lingua a introdurre nel lemmario certi termini che, dopo un
prepotente erompere nel discorso pubblico, spesso diventano
rapidamente desueti, per poi essere rievocati quasi esclusivamente
come cifra di un particolare momento storico. Anche qui potrà
tornare utile un esempio, e il primo che mi viene in mente è quel
«cristargare» che a cavallo tra i
Settanta e gli Ottanta del secolo scorso venne a indicare il
riprodurre la targa automobilistica sui cristalli di una vettura in
modo da scoraggiarne il furto.
Se
qualcosa ci è lecito asserire riguardo al come un
neologismo trova fortuna, ancorché effimera, più
difficile è tentare di capire cosa gliela dia, e questo per la
semplice ragione che la parola solitamente si adatta alla cosa che
intende rappresentare attraverso un processo di reciproco aggiustamento, dato il continuo, seppur talvolta impercettibile, mutare
di entrambe, mentre invece il neologismo pretende di cogliere il
senso di qualcosa che spesso è tutto in fieri, spesso assegnandogli
il senso che non di rado è tutto nella previsione di quel che sarà
il factum, che mostra tutto il limite di una scommessa. Per questo,
quando qualcosa che ci appare nuovo cerca un nome altrettanto nuovo,
la fortuna premierà quello in grado di rappresentarne in modo più
efficace l’indeterminatezza
col ricorso a formule che hanno la pretesa di dare ineffabilità
al vago.
Così
mi pare stia accadendo con la «post-verità», dove il prefisso sta
per «dopo», ma anche per
«dietro», indicando nel contempo qualcosa che verrebbe dopo la
verità, come sua trasformazione in altro, o che le starebbe dietro,
usandola come una maschera. In entrambi i casi, dato il valore
assoluto che si tende a dare alla verità, il termine suona
inquietante, perché implica un inevitabile sminuirsi di quel valore
o, peggio, il suo usurparlo da parte di ciò che, per l’essere
anche solo in minima misura lontano dal vero, è inevitabilmente
falso, dunque scopertamente insidioso.
In
questo porsi dinanzi a un termine del genere pare diventi del tutto
secondario chiedersi se si abbia modo di avere qualche solida
certezza su cosa sia la verità: tutti riteniamo di sapere cosa sia,
almeno quando non ce n’è chiesta la definizione. Le cose si
complicano terribilmente quando siamo costretti a fornirne una, senza
la quale un termine come «post-verità» diventa ancor più
indefinibile di quello che vuol essere per illuderci di aver con esso
colto la sostanza che si vuole assegnare a una particolare e nuova
specie del falso. In altri termini, direi che vero e falso cercano
nella «post-verità» una ridefinizione che risponda al meglio ai
nuovi modi in cui essi ci si ripresentano dinanzi, senza peraltro
poter pretendere di riuscirci, perché non possono riproporsi alla
nostra attenzione senza il carico di ambiguità che li
contraddistingue in radice.
Il
fatto è (e qui riprendo una mia riflessione di qualche tempo fa) che
ogni
definizione di verità
è
una tautologia. Tautologia più o meno manifesta, ma tautologia. Si
va dalla tautologia dichiarata tale col definirla «l’essere
vero»
(De
Mauro) o «ciò
che è vero»
(Treccani), a quella che va in cortocircuito con un termine facente
funzione di sinonimo, per più con realtà,
e allora la verità diventa la «aderenza
alla realtà»
(Palazzi)
o la «rispondenza
piena e assoluta con la realtà effettiva»
(Devoto-Oli)
o, ancora, la «conformità
a una realtà obiettiva»
(Treccani),
dove questa realtà
rimanda
inevitabilmente al vero,
in quanto «qualità
e condizione di ciò che è veramente»
(Palazzi).
Quando
poi dal tentare di definire la verità
si
passa ad analizzare le sue accezioni in ambito filosofico e
scientifico, teologico e linguistico, logico e psicologico, le cose
non vanno meglio, perché «non
c’è una definizione univoca su cui la maggior parte dei filosofi
di professione e gli studiosi concordino, e varie teorie e punti di
vista della verità continuano ad essere discussi»
(Wikipedia),
e perché in ciascun ambito il termine va assumere un significato che
risulta inservibile in un altro.
Si
prenda, per esempio, il significato di verità
per
un teologo come Tommaso, che la ritiene coincidente all’Essere e in
pratica assimilabile a Dio: sarà accezione praticamente inservibile
per un epistemologo come Peirce, che la ritiene il risultato di un
accordo di un determinato gruppo di soggetti, su un determinato
assunto, in un determinato spazio, in un determinato lasso di tempo.
Oppure si prenda il suo significato per un matematico come Gödel,
per il quale non tutto ciò che è vero
è
anche dimostrabile: del tutto incompatibile con la definizione che di
verità
dà
un logico come Frege, secondo il quale il vero
è
categoria illusoria.
Non
va meglio neppure trasferendo interamente il vero
al
reale,
per tenercelo, perché la realtà
è
maledettamente sfuggente ad una percezione che voglia dichiararsi
qualitativamente e quantitativamente assoluta e tradursi in
conoscenza oggettiva: offrirà in se stessa gli strumenti per
valutare la congruenza tra un aspetto del reale e un suo
corrispettivo, in ciò che dunque avrà efficacia di mera
dimostrazione di una congruenza interna ad un sistema, del quale però
la conoscenza soggettiva è parte inalienabile. E così la realtà
sarà
comprensibile, ma mai interamente, né sarà mai possibile ridurla a
pura oggettività, perché ad essa è connaturata la frammentarietà
della percezione e della comprensione relativa, che non può mai
tradursi in conoscenza assoluta.
È
in questo punto, che poi è quello dove ci si dovrebbe arrendere
all’impossibilità dell’onniscienza, dell’impossibilità di
rappresentarci il vero
al
di fuori di uno spazio soggettivo, che nasce la trascendenza. Con
essa si fa strada in molti l’idea che l’assoluto sia una meta e
che la verità sia un fine. Tutto è promesso all’uomo in una
verità assoluta, tutto gli è chiesto in cambio di quella. Quasi
sempre, allora, accade che il soggettivo, per questa sua vorace fame
di assoluto, cerchi di imporsi come oggettivo, non di rado con mezzi
assai opinabili, assai opinabilmente giustificati dalla bontà del
fine, tutto illusorio.
È
che forse dovremmo sbarazzarci di una parola come «verità»
o usarla in modo assai più cauto, perché a darle il significato di
qualcosa indiscutibile si corre il serio rischio di conferire a
qualcuno l’autorità
di impedire ogni discussione su cosa sia vero e cosa no, il che è
già di per sé una negazione della verità, almeno a intenderla come
risultato sempre parziale, sempre imperfetto, di una conoscenza che
ha negli stessi suoi strumenti gli invalicabili limiti.
Dichiarazione
di scetticismo radicale? Tutt’altro.
Direi sia solo un monito a non fidarsi mai della piena
intelligibilità di un factum, tanto meno quando è ancora in fieri:
ogni sua comprensione è giocoforza incompleta, perché quello che ce
lo ridà è sempre un modello, che raramente si rivela
incorreggibile, e questo vale per tutto ciò che si fa oggetto della
conoscenza, dall’infinitamente
piccolo all’infinitamente
grande, passando per quello che c’è
in mezzo: quando la conoscenza non ha timore di abbandonare un
modello per adottarne un altro che sembri più adeguato alla
comprensione, diventa inevitabile considerare la transitorietà di
quella che fino a quel momento si era commesso l’errore di reputate
come ultima e inemendabile verità sulla tal cosa, sulla tal persona,
sul tal accadimento. Con
ciò dovrebbe apparire sufficientemente ridicolo l’uso
di un termine che è immancabilmente appiccicato a ciò che si
ritiene definitivamente acquisito, poco importa se in forza delle
nostre personali convinzioni o di quelle di un’autorità
cui conferiamo il potere di pensare per noi, e invece spesso ne
facciamo perfino abuso, per costruirci sicurezze che vengono
regolarmente spazzate via dal semplice cambiamento di prospettiva che
consegue al costante mutare del tempo e dello spazio che sono le
coordinate del nostro essere. Si dovrebbe rinunciare a parlare di
«verità» per ciò che hic et nunc ci sembra indiscutibile: sarebbe
di gran lunga meno pericoloso l’uso
di un termine come «comprovabilità», che all’assunto
altrimenti definito «vero» conferisce un valore di affidabilità
esclusivamente sulla possibilità di controllo, convalida e
condivisione che è nella facoltà di chiunque sia disposto a
rispettare le elementari leggi della logica, che trasposte sul piano
dell’argomentazione
sono le sole a poter dar ragione di ciò che è corretto, in quanto
poggia su premesse incontestabili, valido, perché rifugge da
tautologie o contraddizioni, e persuasivo, come efficace risultato
del processo che ne articola lo sviluppo in un’affermazione.
Sostanzialmente si tratterebbe di adottare il metodo scientifico per
tutto ciò che liquidiamo troppo sbrigativamente come «vero» o
«falso». Ve ne sarebbe anche per poter rinunciare a parlare di
«post-verità», che almeno a voler prendere per buona la
definizione che ne è comunemente data, sarebbe «una notizia
completamente falsa, ma che, spacciata per autentica, è in grado di
influenzare una parte dell’opinione
pubblica» (Wikipedia): c’è
già un termine che risponde a questa descrizione, ed è «fattoide».
Preferirlo a «post-verità» presenta almeno due vantaggi. Il primo
è che ci consente di evitare l’implicita
assunzione di categorie come «vero» e «falso» che pressoché costantemente esigono il ricorso a un’autorità
che è da presupporsi onnisciente. In secondo luogo, il «fattoide»
include anche quella minima deformazione del factum come
effettivamente comprovabile (sul quale, cioè, sia possibile il
controllo, dandogli convalida e perciò rendendolo condivisibile) che
comunque è in grado di alterarne il senso.
Stabilito
che una «post-verità» non è altro che un «fattoide», e che con
«fattoide» perde la pericolosità che assume nel reclutare
difensori di una «verità» che non deve mai essere messa in
discussione, c’è
da considerare perché si sia sentita la necessità di coniare –
chiedo scusa per il bisticcio – un nuovo neologismo per qualcosa
che è sempre esistito, almeno fin da quando si è spacciata per
autentica la notizia completamente falsa che l’uomo
sia un mix di fango e alito di Dio, con la conseguente influenza su
gran parte dell’opinione
pubblica. Forse è proprio il ricorso al prefisso «post-» a
potercene dare una ragione, pensando a quale funzione sia chiamato
per altri neologismi che pure lo sfruttano per dare al termine cui è
legato, quasi sempre con più efficace resa di significato, che
comunque sembra deliberatamente conservare un che di ambiguo se non
di vago, il senso di qualcosa che di quel termine indica il
superamento, la revisione, l’evoluzione
in altro che, se non ne è la negazione, ne è almeno la
riconsiderazione in chiave critica, se non addirittura polemica,
quasi sempre a decretarne la crisi («post-modernità»,
«post-democrazia», ecc.). Se questa interpretazione coglie nel
segno, diremmo che la «post-verità» viene sentita come una seria
minaccia per la «verità», con la quale concorre in persuasione.
Tanto più seria, questa minaccia, perché mostra di riuscire a
ottenere incredibili successi che resistono perfino alle
inoppugnabili smentite di quello che ha spacciato per «vero»
e poi è stato dimostrato «falso».
Come
è possibile che questo accada? La domanda assume con sempre più
frequenza toni preoccupati, muovendo a chiedersi cosa vi possa metter
freno. Giacché poi si dà per pacificamente assodato che la
«post-verità»
nasca nel web, e lì acquisti forza, fino a esorbitarne, per andare
ad adulterare la «verità»
perfino nei santuari in cui fino a poco tempo fa essa era custodita
con venerazione e difesa senza eccessiva fatica, la soluzione sembra
dover essere trovata nel ucciderla sul nascere, e lì dove prende
vita. Soluzione necessariamente violenta, questo è ovvio, ma come
non ritenerla sacrosanta, questa violenza, visto che è in difesa
della «verità»? Dando questo nome a ciò che si ritiene anteriore
e superiore all’interpretazione
del factum, la sua interpretazione consolidata può ben dirsi
trascendente. Altra cosa sarebbe chiamare «fattoide» il factum che
non regge al saggio di comprovabilità, e faticare quanto dovuto a
mostrarne l’infondatezza, e dunque l’inattendibilità:
significherebbe scendere nell’agone
fidando nella bontà dei propri argomenti, ad averne di corretti,
validi ed efficacemente persuasivi. La tentazione di usare la
violenza è comprensibile, quando non si è certi di averne o quando, pur certi che siano validi e corretti, si dispera possano essere anche persuasivi.
Ci sarebbe un’altra soluzione, ma imporrebbe un cambiamento di prospettiva: da «come può, il falso, sembrare vero?», la domanda dovrebbe esser posta in altro modo: «come può, l’agorà, farsi persuasa al falso più che al vero?». Superando le categorie di «vero» e «falso», la domanda non è difficile: giacché la persuasione non è che la resa alla forza di un argomento, vi sono condizioni nelle quali questa resa si può più facilmente ottenere grazie a una fallacia che a un retto argomento. Ma cosa caratterizza queste condizioni? L’alta vulnerabilità a strumenti retorici di forte impatto, ancorché invalidi e scorretti. E cosa determina tale vulnerabilità? Un perdurante stato di soggezione a «verità» che per affermarsi si sono servite proprio di tali strumenti. In conclusione, occorre riconoscere che la tendenza a credere in qualcosa che non ha i requisiti di «comprovabilità» non è altro che il prodotto di una lunga storia che si è data solco nella indiscutibilità di alcune «verità»: non si riesce a far troppa differenza tra «verità» e «post-verità» quando non si è avuta educazione a ragionare.
Ci sarebbe un’altra soluzione, ma imporrebbe un cambiamento di prospettiva: da «come può, il falso, sembrare vero?», la domanda dovrebbe esser posta in altro modo: «come può, l’agorà, farsi persuasa al falso più che al vero?». Superando le categorie di «vero» e «falso», la domanda non è difficile: giacché la persuasione non è che la resa alla forza di un argomento, vi sono condizioni nelle quali questa resa si può più facilmente ottenere grazie a una fallacia che a un retto argomento. Ma cosa caratterizza queste condizioni? L’alta vulnerabilità a strumenti retorici di forte impatto, ancorché invalidi e scorretti. E cosa determina tale vulnerabilità? Un perdurante stato di soggezione a «verità» che per affermarsi si sono servite proprio di tali strumenti. In conclusione, occorre riconoscere che la tendenza a credere in qualcosa che non ha i requisiti di «comprovabilità» non è altro che il prodotto di una lunga storia che si è data solco nella indiscutibilità di alcune «verità»: non si riesce a far troppa differenza tra «verità» e «post-verità» quando non si è avuta educazione a ragionare.